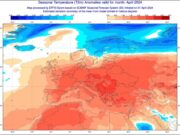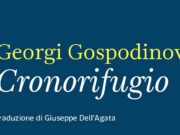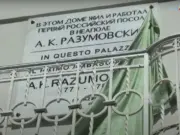«Continuano ancora a esistere ingenui osservatori di sé, i quali credono che vi siano certezze immediate, per esempio: io penso o io voglio. […] ci si dovrebbe pure sbarazzare, una buona volta, della seduzione delle parole! Se scompongo il processo che s’esprime nella proposizione: io penso, ho una serie d’asserzioni temerarie, la giustificazione delle quali è forse impossibile, – come per esempio, che sia io a pensare, che debba esistere un qualcosa, in generale, che pensi, che pensare sia un’attività e l’effetto d’un essere che è pensato come causa, che esista un io; infine che io sappia che cos’è pensare. […] Donde prendo il concetto di pensare? Perché credo a causa ed effetto? Che cosa mi dà il diritto di parlare d’un io come causa, e infine ancora d’un io come causa dei pensieri?»
In Al di là del bene e del male, Nietzsche si interroga sul soggetto e sulla falsificazione relativa alla certezza dell’esistenza d’una volontà e di un’unità dell’io. Ciò significa porsi dei quesiti per comprendere chi abbia istituito la forma d’esistenza che viene definita soggetto (io) e, soprattutto, in quali circostanze, in quale campo di forze e con quali effetti. La ricerca filosofica di Nietzsche è in fondo, nient’altro, che pratica filologica: una pratica che non può non restare sempre infinitamente aperta. Non vi è nulla al di fuori della pura interpretazione. L’insegnamento nietzschiano non mira alla vera conoscenza (verità), ma solo a una perpetua scepsi d’interpretazioni casuali senza fine. Nietzsche attua l’eclissi del soggetto attraverso la sua opera di genealogia. Egli de-centra l’io e lo decifra in quanto finzione, in quanto unità illusoria; infatti l’uomo è una pluralità che s’è immaginato unità. L’io è quindi una forma che riduce e imprigiona forze essenziali della vita: tutto ciò che è molteplice, in divenire, libero, corporeo, materiale, viene svalutato e negato in nome di valori superiori o trascendenti. Il fondamento e il principio gerarchico di questa unità immaginaria vengono sublimati in un ambito spirituale, definito come coscienza nettamente contrapposta al corpo e alla materia che a essa sono, erroneamente, subordinati. Infatti Nietzsche afferma che la nozione d’individuo si mostra fallace. Non c’è soggetto, non c’è io.
«Io dici tu, e sei orgoglioso di questa parola. Ma la cosa ancora più grande, cui tu non vuoi credere – il tuo corpo è la sua grande ragione. Essa non dice io, ma fa io».
Nietzsche scardina queste credenze psicologiche e morali attraverso la trasvalutazione di tutti i valori; infatti Zarathustra, proclamando a gran voce la morte di Dio, ha annunciato la morte dell’uomo e la necessità di un suo «oltrepassamento». Con la fine della religione e del sistema di valori a essa connesso, l’uomo è condannato a essere oltrepassato da un oltreuomo (superamento del soggetto). Con la negazione della conoscenza e della morale, cioè della verità e del bene, Nietzsche afferma la visione dionisiaca. Dioniso è il dio della pura esistenza, della pluralità contraddittoria senza aspirazioni di redenzione, senza giustificazioni fondate su valori originari; è il dio del libero gioco delle forze naturali, dei contrasti irriducibili, non componibili in un senso superiore, delle infinite metamorfosi, della creazione e della distruzione, senza origine, senza fine, senza identità, senza essenza, senza verità. Ogni presunta origine, fine, identità, essenza, verità, riconduce a forze che non hanno, a loro volta, né origine, né fine, né identità, né essenza, né verità. Tutto ciò che è ritenuto stabile e provvisto di senso si rivela fluido e insensato, ogni supporto certo viene meno. Ogni io è superfluo; tutti i tentativi di redenzione della finitezza e limitatezza umana sfociano in altrettante negazioni della vita. Nel teatro della vita tutto è maschera. Tutte le verità affermate nella storia sono altrettante maschere che nessuna verità fondante può smascherare. Nietzsche decostruisce il linguaggio, la logica, la morale e l’intera metafisica occidentale.

«Io vi insegno il superuomo L’uomo è qualcosa che deve essere superato. L’uomo è un cavo teso tra la bestia e il superuomo – un cavo al di sopra di un abisso».
Poesia e Distruzione dell’Io
«È falso dire: Io penso: si dovrebbe dire io sono pensato. Io è un altro (Je est un autre). Tanto peggio per il pezzo di legno che si ritrova violino, se l’ottone si sveglia tromba, non è affatto colpa sua; e sprezzo agli incoscienti, che cavillano su ciò che ignorano completamente!»

A. Rimbaud incarna il desiderio di una poesia nuova, oggettivamente visionaria, che esce dal soggettivismo e dal formalismo artistico. Ciò sarebbe avvenuto, secondo lui, attraverso lo sgretolarsi dei sensi, attraverso il confondersi delle usuali distinzioni di senso tra parole, colori e suoni, attraverso la necessità d’esprimere una lingua nuova. «Io è un altro». L’io diventa un elemento estraneo alla coscienza, non sembra più essere a fondamento del pensiero, né poter avere uno statuto privilegiato e centrale. L’io non pensa, è pensato, assiste allo schiudersi del pensiero come uno spettatore esterno, come un altro. L’io è del tutto impotente di fronte al pensiero che è un flusso che esce spontaneo dalle profondità. Rimbaud attua un decentramento dell’io, infatti quest’ultimo non è soggetto, ma una specie di oggetto rispetto ai pensieri, una forma vuota a cui vengono associati i pensieri, che nascono indipendentemente da esso. Rimbaud raggiunge un livello di consapevolezza, quello che gli consente di dire: «Io è un altro»; che permette di smascherare l’alienazione dell’io, che permette d’indicare gli incoscienti, i dormienti, e cioè coloro che: «cavillano su ciò che ignorano», quelli che pensano che l’io sia a fondamento del sapere. Compito del poeta è definire la quantità d’ignoto che si ridesta nell’anima universale del suo tempo, è ritmare e vivere il divenire.
Il Buddhismo e l’Inesistenza dell’Io
«Monaci, tutto brucia! E cosa brucia, o monaci?
La vista brucia, o monaci, le forme e i colori bruciano, la coscienza visiva brucia, il contatto visivo brucia, e qualsiasi sensazione sorga in dipendenza dal contatto dell’occhio con i suoi oggetti – sia essa percepita come piacevole, spiacevole o neutra – anche questa brucia. Mediante cosa brucia? Brucia mediante il fuoco dell’attaccamento, il fuoco dell’avversione, il fuoco della confusione. Brucia, vi dico, a causa della nascita, della vecchiezza e della morte, della pena, del lamento, del disagio, dell’angoscia e dello scoramento». (Il Sermone del Fuoco)

La dottrina dell’anātman afferma l’inesistenza di un io individuale, essendo tale illusione figlia della percezione della realtà convenzionale, figlia della credenza che ci sia qualcosa di trovabile e concreto, qualcosa di sostanziale e monolitico. Ma questo senso dell’io, d’identificazione, è l’ignoranza alla base di tutte le altre afflizioni mentali, è lo stimolo del soffrire (dukkha). In realtà l’io, la persona, il sé, sono qualcosa di puramente nominale. Tanto più è presente l’io personale, tanto meno è possibile l’ascesa verso il trascendente. Buddha indica nella realizzazione del Shunyata (vacuità – annullamento del sé) la soluzione, il superamento di dukkha (patimento). Bisogna calarsi con disciplina nell’esperienza del mistero, attraverso la rettitudine (samyag). Nella filosofia buddhista l’ignoranza e l’idea di ego sono la stessa cosa. Infatti l’ignoranza sostiene l’ego, in esso trova la sua sede originale. Ma con la realizzazione l’ordine istituito dall’ignoranza viene sovvertito radicalmente. L’io va negato, e bisogna recare preminenza all’universalità dell’inter-dipendenza. Il buddhismo evidenzia il fatto che la sensazione di sé sia apparente, sorge da un caos noumenico originario. Bisogna riconoscere l’evanescenza e la vacuità del fenomeno della soggettività, perché si possa vivere l’illuminazione, perché si possa raggiungere il Nirvāṇa.
Ma dal vuoto cosa si vede? Assenza di turbamenti, quiete, semplicità, risoluzione, rasserenamento.
Gianmario Sabini