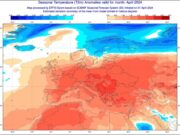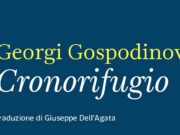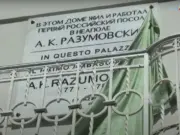Da quando la Covid-19 ha obbligato tutti alla quarantena nella propria abitazione, il piacere della lettura è stato riscoperto ed è ricominciata la corsa al bestseller. Molti leggono per passione, alcuni per studio, altri per informazione, altri ancora lo fanno alla ricerca di indicazioni o di aiuti su come affrontare la vita durante la pandemia e, soprattutto, su quali cambiamenti aspettarsi al termine della stessa. Gran parte di questi ultimi si sono imbattuti in un romanzo che, anche nella sua epoca, non è passato certo inosservato: “La peste” di Albert Camus; da ormai diverse settimane nella classifica dei titoli più venduti.
Il romanzo, pubblicato nel 1947, riscosse da subito un grandissimo successo e ottenne anche un Prix des Critiques, non risultando per nulla indifferente alla letteratura del tempo. Ancora sugli strascichi del dopoguerra, Camus seppe rendere allegoricamente il ruolo del male che aveva imperniato i tempi da poco passati e rimaneva latente nel succedersi degli eventi. Un ruolo intenso e tragico affidato dall’autore nelle mani della peste che, come l’epidemia che sta affliggendo oggi il mondo intero, si era immessa silenziosa nella città algerina di Orano, che diede i natali allo stesso Camus e che, negli anni quaranta del novecento, si trovava ancora sotto dominazione francese. Un pericolo epidemico inizialmente sottovalutato e creduto di poco conto, ma che, non dopo molto tempo, si fece breccia negli abitanti della città, rendendo le proprie case la loro unica salvezza.
Orano è descritta dall’autore come una città sempre di corsa, oberata dal lavoro e fin troppo distante dai sentimenti reali, dove si corre contro il tempo, che manca sempre, e non ci si può permettere di ammalarsi o fermarsi. Risulta impossibile non notare un parallelismo con le città di oggi. Un luogo dove passano indifferenti anche le morie di topi, troppo evidenti alla natura e poco importanti per chi, a questo, non ha tempo di dar conto. Ma il male è dietro l’angolo e, ben presto, la strage di topi, inizia ad essere una strage di uomini. A notarlo è il protagonista del romanzo, Rieux, un medico francese residente nella città, il quale è reso da Camus contemporaneamente attore e narratore in terza persona della vicenda. La narrazione appare esser frutto delle annotazioni, riportate su un taccuino scritto dal co-protagonista della storia, Tarrou; che fanno luce sugli eventi addentrandosi nei particolari pungenti dell’epidemia morbosa.
Questa peste costringe alla vita nelle case, fa aumentare le distanze umane e erige mura tra ogni singolo individuo, sottomettendo ciascuno alla paura dell’untore. In questa situazione di stasi, dove il tempo sembra essersi fermato e l’impotenza diventa sentimento comune; gli unici capaci di poter fare qualcosa sono i medici, i volontari e, chiunque operi in questi campi a sostegno della popolazione. Camus li rende, infatti, protagonisti indiscussi, affiancandogli personaggi di buon cuore, che rinunciano a se stessi per aiutare gli altri e che, spesso, sono i primi a rimetterci la vita. Nella morsa del terrore però, emergono anche gli sciacalli, condensati dall’autore nella figura di Cottard, un uomo folle che lucra sulla penuria dei generi alimentari e sull’emergenza, facendo in modo di accrescere soltanto il proprio ego. La guerra contro la strage incontrollabile fa risaltare la distanza tra l’umanità e l’empietà e, in conclusione, la prima sembra avere la meglio. L’autore, tuttavia, lascia nel finale un senso di incompletezza e di sospensione: il male appare sconfitto, ma rimane sempre celato dietro l’angolo e pronto a riemergere di nuovo.
Quella di Albert Camus era soltanto una metafora, seppur di successo; eppure oggi si vive esattamente quanto raccontato. Le città sono isolate, le persone sono segregate nelle loro abitazioni, non esistono i contatti umani e pochi sono coloro che aiutano gli altri. La paura, nascosta nelle emozioni e nei comportamenti dei personaggi del romanzo è, anche oggi, tangibile sui volti di chi lotta contro la peste invisibile. In un mondo, ormai prettamente tecnologico, sorprendentemente simile alla città di Orano, i lettori trovano un conforto misto ad incertezza nella lettura di questo scritto. Molti nell’ossessionata ricerca di presagi, vi ritrovano inoltre un che di inquietante ed oscuro, e cresce in loro l’inquietudine verso il futuro che spetta al mondo; mentre si fa strada nello stesso la speranza di uscire da «questo imprigionamento che porta con sé una terribile libertà nei riguardi di tutto quanto non sia il presente».
Francesca Scola