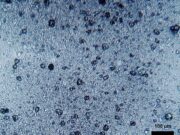Il colosso farmaceutico Bayer AG, che ha acquisito nel 2018 l’azienda americana di biotecnologie agrarie Monsanto, elargirà miliardi di dollari per chiudere centinaia di migliaia di cause giudiziarie relative ai gravi danni alla salute contro il diserbante Roundup, “probabilmente cancerogeno”, secondo l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) facente capo all’OMS. La multinazionale non si è limitata ad aggirare gli ostacoli giuridici facendo leva sulle infinitamente maggiori disponibilità finanziarie rispetto ai querelanti, ma si è resa responsabile anche del sabotaggio e dell’intimidazione dei suoi critici nel mondo della scienza e del giornalismo per proteggere la propria posizione ed insabbiare i propri crimini contro l’uomo e l’ambiente.
Non c’è pesticida al glifosato che possa estirpare la malerba del profitto ad ogni costo sociale e ambientale: l’infestazione prolifera senza controllo in una società nella quale le asimmetrie economiche diventano irrimediabilmente asimmetrie di potere.
Da Monsanto a Bayer, la parabola dell’erbicida più tristemente famoso
L’ennesimo “processo del secolo” in atto è solo l’ultimo passaggio di un travagliato percorso giudiziario, che nasce da un altrettanto serrato discorso scientifico. Al centro del contendere, l’erbicida a base di glifosato prodotto da Bayer – Monsanto, il celeberrimo Roundup. A partire dagli anni ’70 il composto chimico appena citato ha praticamente monopolizzato il mercato, per l’insuperata capacità di eliminazione di piante infestanti e di protezione delle colture agricole, che siano esse OGM o meno, e nel giardinaggio, e la formula del preparato, scaduto il brevetto nel 2001, è stata utilizzata anche da altre aziende del settore (soprattutto cinesi).
Le implicazioni dannose per l’ambiente e la salute di un uso così estensivo e sistematico del glifosato (circa 800.000 tonnellate nel 2015) sono controverse, ma dimostrate da diversi studi indipendenti e da agenzie che operano nel settore. Il composto oggi proprietà di Bayer deteriora gravemente gli habitat degli agro-ecosistemi ed è altamente tossico per organismi viventi quali insetti (tra cui gli impollinatori), anfibi, anellidi e microrganismi, con conseguente perdita di biodiversità. La sua capacità di percolazione negli strati del sotto-suolo è assai elevata, e arriva a compromettere le falde acquifere. Inoltre, aumenta la cagionevolezza alle malattie e la resistenza agli erbicidi delle colture stesse e persiste in tracce rilevabili e potenzialmente tossiche anche nei prodotti agricoli finali. Insomma ad essere potenzialmente soggette a degradazioni inquinanti sono sia idrosfera che rizosfera, ossia quella parte del suolo che circonda le radici essenziale per la salute e l’assorbimento dei nutrienti da parte delle piante.

La comunità scientifica (la già citata IARC si contrappone all’agenzia europea per la sicurezza alimentare EFSA) dibatte invece serratamente sulla pericolosità delle concentrazioni di glifosato nell’acqua o negli alimenti, e quindi dell’identificazione di un potenziale pericolo per la salute pubblica e dell’entità del rischio associato in riferimento alla cancerogenicità del glifosato, soprattutto relativa al linfoma non-Hodgkin, un letale tumore del sangue. A tal proposito, contro l’allora Monsanto, oggi Bayer, sono state intentate numerose cause giudiziarie, diverse delle quali hanno portato a risarcimenti milionari. Il caso dei coniugi Pilliod e quello di Dewayne Johnson, primo a vincere una causa contro il colosso delle biotecnologie agrarie, sono solo i più noti: si è arrivati ad una sorta di class action che conta complessivamente più di 100.000 processi pendenti nel 2020, e che può contare sul supporto mediatico e non di diverse associazioni ambientaliste e campagne di boicottaggio. Diversi Paesi stanno discutendo anche sul divieto di commercializzazione: partendo dal presupposto che la pericolosità del glifosato non è ancora stata riconosciuta, l’effettiva e comprovata sussistenza del danno da diserbante Roundup, riconosciuta anche in sede legale, deriverebbe soprattutto dalla possibilità di avvelenamento accidentale, insufficientemente specificato e rettificato dall’azienda.
Ma le responsabilità di Monsanto e di Bayer non possono esaurirsi nella dialettica scientifica: la multinazionale ha inquinato, oltre al pianeta, soprattutto il libero dispiegarsi del dibattito pubblico con azioni oltre il limite della legalità.
“Il crimine non paga”, ma i crimini possono essere pagati
Se la decisione di Bayer di avvalersi della cifra record di 11 miliardi di dollari per chiudere quasi il 75% delle cause giudiziarie intentate contro la compagnia può essere ancora riferibile alla sfera dell’opportunità etico-morale e delle coordinate ideologico-politiche, non possono di certo esserlo i tentativi spregiudicati di condizionare i processi scientifici e di intimidazione e sabotaggio dei suoi critici nel mondo della ricerca e dell’informazione.
Innanzitutto, una parte della somma concordata negli accordi legali verrà stanziata da Bayer per finanziare un panel scientifico che avrà come obiettivo la verifica definitiva della pericolosità del glifosato. Se si determinasse che il glifosato non fosse cancerogeno, ai querelanti che hanno accettato l’accordo sarà proibita qualsiasi azione legale futura contro la società, mentre i restanti vedrebbero le proprie richieste di giustizia comunque compromesse da un parere scientifico contrario. Quella che secondo il CEO di Bayer, Werner Baumann, è la definitiva chiusura di una fase di incertezza insostenibile per azienda e consumatori, somiglia più che altro ad un indebita intromissione nel dibattito scientifico attraverso onde anomale di denaro ed esperti legati economicamente alla compagnia, con il malcelato obiettivo di ripulire l’immagine del marchio e salvaguardare profitti e quotazioni finanziarie in caduta libera.

Del resto, i condizionamenti di Bayer e Monsanto non si esauriscono qui: i documenti aziendali pubblicati dal Guardian hanno rivelato l’operatività di una macchina del fango che tramite avanzatissime tecniche di intelligence monitorava e in seguito diffamava e screditava sistematicamente personaggi che si fossero mobilitati contro il diserbante Roundup. Carey Gillam, penna di Reuters autrice di inchieste e libri che certificavano i legami esistenti tra diserbante e il cancro, il cantautore Neil Young, fondatore della ONG “US Right to Know”, sono stati i principali destinatari di azioni coordinate di boicottaggio nei dibattiti e su Amazon, penalizzazione su motori di ricerca come Google, esplicite pressioni editoriali per l’allontanamento dalla redazione “ad ogni costo” nel caso della giornalista, e tracciamento social e monitoraggio tout court per intentare possibili cause legali nel caso dell’artista. Un quadro operativo meticolosamente organizzativo, denominato addirittura con un nome in codice,“Project Spruce“, nei documenti trapelati. Il sistema ha coinvolto anche scienziati e ricercatori chiamati ad esprimere pareri sul glifosfato, che sarebbero stati destinatari di corrispondenze economiche opache e/o inopportune con l’azienda con il fine esplicito di occultare dati scientifici scomodi.
Si tratta di comportamenti segnati da efferatezza e cinismo, che Bayer ha commentato con estremo semplicismo. Silenzio stampa assoluto su “Project Spruce“, e solo qualche commento sconnesso e sofisticamente debole sulla questione del condizionamento del dibattito scientifico: i finanziamenti si sarebbero resi necessari per garantire un dialogo “informativo ed equilibrato” (!) sulla questione, scevro da posizioni pregiudiziali, e gli esperti coinvolti nelle ricerche promosse dalla società sarebbero semplicemente stati debitamente ricompensati, considerato che nessuno lavora gratuitamente. Se i crimini di Monsanto e Bayer non sono ancora del tutto accertati dalla scienza, sono eloquentemente sotto gli occhi di tutti per quanto riguarda queste intollerabili manipolazioni e intromissioni, perpetrate a suon di mezzi materiali.
Un’ordinaria storia di capitalismo immorale
Un caso da manuale per riflettere innanzitutto sulle contraddizioni di un modello di sviluppo che contrappone rovinosamente e insanabilmente le finalità di profitto al diritto alla salute e alla tutela ambientale, soffocando qualsiasi ipotesi di socializzazione ecologica del sistema economico, ma anche le più basilari richieste di responsabilità pubblica e trasparenza, facendo pesare la sproporzione delle forze in campo. I crimini commessi da Bayer, infatti, si iscrivono pienamente nel solco di quel “capitalismo immorale” che si avvale della superiore disponibilità economica per comprarsi la verità un pezzo alla volta, processuale o scientifica che sia.
La determinazione con la quale la multinazionale ha cercato di mettere a tacere ogni voce critica è prova tangibile del fastidio e sprezzo che certa impresa nutre nei confronti dei diritti e della sicurezza delle persone, ed è il riflesso di una società che necessita urgentemente di nuovi contrappesi per sostanziare i suoi principi di uguaglianza, giustizia e democrazia.
Luigi Iannone