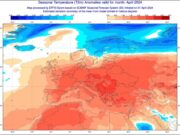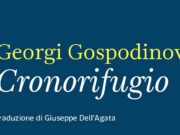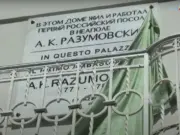Nel racconto storico degli ultimi duecento anni, è impossibile non citare il lavoro del rivoluzionario Emile Zola, capace nel corso delle sue opere di dipingere un quadro quanto mai amaro e chiaroscurale della vita e dei suoi interpreti. Nel romanzo “La bestia umana”, dunque, è possibile ritrovare e riscontrare le peculiarità che non solo hanno contraddistinto la Francia del’800 ma soprattutto quelle contraddizioni e debolezze che non hanno smesso di sollecitare il cuore degli uomini.
Amore, passione, guerra, violenza e redenzione: queste le parole chiave per poter dare una chiave di lettura quantomeno sincera alla distruttiva e a-significante opera che rappresenta “La bestia umana”. Ci troviamo infatti nel mondo del genio di Zola: il suo penultimo romanzo si innesta come un ingranaggio ben oliato e in maniera autonoma ma efficace nella saga della famiglia dei Rougon Marcquat, che comprende ben 20 libri ed è messo in scena nella Francia del XIX secolo. L’autore, di origini italiane, si propone di creare un romanzo sperimentale, guidato dagli stessi criteri di obiettività che dominano la ricerca scientifica. Risaputo infatti è come l’autore cercasse di sviluppare prima di tutto una cultura di stampo realista, avvicinandosi al positivismo e all’importanza del metodo e della ricerca scientifica.
La figura del personaggio principale è ricoperta da Jacques Lantier, il quale è vittima di pulsioni omicide. Si trova bene solo in compagnia del fuochista Pecqueux sulla Lison, la locomotiva a vapore con la quale percorre la linea Paris-Le Havre. Il destino che continua a fare da padrone nelle opere del francese porta il protagonista del romanzo di Zola ad incontrare una giovane donna, Séverine il cui marito Roubaud, vicecapo della stazione di Havre, ha appena assassinato l’amante della moglie, Grandmorin. Séverine diventa l’amante di Lantier e gli suggerisce di eliminare il suo ormai ingombrante marito. Tuttavia durante una crisi psicotica di Lantier è lei stessa a restare uccisa.
Quando si intraprende l’intrigante viaggio nell’universo bucolico dell’infinita fantasia di Zola, si ha la possibilità di riconnettersi con quel mondo così lontano da quello odierno, attraverso lo sviluppo da parte dell’autore di ogni particolare: ogni dettaglio viene esaltato e portato in auge come essenziale per il proseguimento della stessa trama. La prima scena che ci viene proposta è la visione da questa casa dismessa, dalla quale una povera donna malata vede passarsi davanti tutte le mattine, da quando la rivoluzione industriale ha fatto il suo corso, un treno. Il treno come simbolo di progresso, ma non solo. La donna, infatti, si sofferma non su un’immagine in particolare, ma su tutti quei volti che vengono sballottati dal “movimento della bestia in movimento”, ognuno con una storia diversa, che per la prima volta si sta approcciando a quel mondo fatto di ferro e acciaio, legno e metallo e vede la natura piegarsi al volere e al sudore dell’uomo.
Ed è poi l’uomo stesso a farne le spese. Questo romanzo non è una critica allo sviluppo tecnologico ma, più verosimilmente, allo stesso principio capitalista che, con encomiabile zelo, ha fatto sì che essa prendesse le veci dei sogni e delle speranze che albergavano un tempo in ciò che la natura aveva di più caro e accudiva con maggior preoccupazione. Quest’uomo non è più cullato dalla brezza della natura che si staglia incontrastata nell’immaginario del poeta, ma si impone invece come padrone e dominatore del mondo che lo circonda, ma è solo una mera illusione. Quest’uomo che perde i contatti con la sua propria natura e l’assoggetta alle necessità che il tempo, inesorabile con il suo scorrere, ci pone innanzi al cuore e all’anima di una società annichilita e stremata.
Il vulnus letterario che si è venuto a formare fino ad ora non rappresenta solamente la divisione sociale e strutturale che l’opera di Zola ha voluto sottolineare con così tanta fermezza, bensì uno scontro di civiltà che mette la nostra generazione dinnanzi ai problemi di quella stessa che ci ha preceduti: la divisione sociale avvenuta con l’avvento delle rivoluzioni industriali, prima, e del neo capitalismo, dopo, hanno fatto sì che avvenisse un appiattimento nel grado culturale e umano del popolo europeo; il quale resta soffermato agli istinti di sopravvivenza primari che non lasciano scampo al destino e forgiano inesorabilmente la decadence di tutti gli uomini.
Un romanzo quello di Zola che, dunque, si pone come spartiacque nella retorica francese che, da una parte, continua a condannare l’operato del socialismo progressista e, dall’altro, non può fare a meno di consolidarsi in quell’immaginario benevolo e straripante del danaro: unica fonte di salvezza per ogni spirito lasciato ormai libero di spendersi come più gli aggrada.
Niccolò Inturrisi