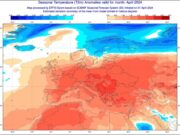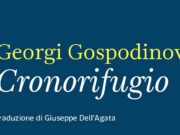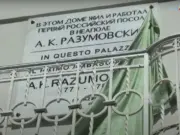Stoner esce in edizione Oscar Mondadori (traduzione di Stefano Tummolini): un buon motivo per parlare ancora una volta della magia dietro quello che secondo molti è il romanzo perfetto – e “L’uomo che scrisse il romanzo perfetto” è il titolo di una biografia di John Williams: il riferimento è proprio a Stoner.
C’è stato infatti un periodo, compreso tra il 2011 e il 2013, in cui accadde qualcosa di molto bello e prezioso nella comunità mondiale dei lettori: scoppiò la cosiddetta “stonermania”. Oggi ancora una volta non siamo sazi di Stoner, come se volessimo spremerne il segreto, rileggendolo ancora una volta e restando affascinati da quel senso profondo di pienezza che un romanzo del genere è capace di regalare; una pienezza che dovrebbe essere smentita da ciò che la trama racconta: una vita semplice, quasi piatta, di un uomo qualunque, talmente normale da non avere il minimo interesse per nessuno. Non proprio ciò che invoglierebbe un lettore. Ma una volta finita l’ultima pagina il ricordo di quest’uomo non riesce più a lasciarci. E torniamo sul luogo del delitto per cercare le tracce di tanta bellezza, non sapendo dove e come ci ha investiti.
Tutto inizia nel 2011 con la traduzione francese di un vecchio romanzo americano sconosciuto ai più, uscito la prima volta nel 1965 e raramente ristampato, che alla sua pubblicazione fu ignorato da chiunque; questo romanzo, Stoner, era stato scritto da John Williams 50 anni prima: Williams peraltro è un autore statunitense morto nel 1994, dalla carriera poco prolifica (quattro romanzi, due raccolte di poesie) e di fama modesta – per quanto vincitore del National Book Award nel 1972 con “Augustus“. Eppure per qualche misterioso motivo il titolo stava correndo di bocca in bocca, come se tutti si fossero resi conto di un talento appena esploso. Editori spagnoli, inglesi, israeliani erano entusiasti di accaparrarsi i diritti per la traduzione, il passaparola cresceva, scrittori di peso (tra cui Ian McEwan) ne tessevano le lodi. In Italia è stata la casa editrice Fazi a pubblicare il libro. John Williams diventa a decenni dalla sua morte un autore di culto e anche gli altri suoi bei romanzi sono riscoperti e ripubblicati. Qual è il mistero di Stoner?

“William Stoner si iscrisse all’Università del Missouri nel 1910, all’età di diciannove anni. Otto anni dopo, al culmine della prima guerra mondiale, gli fu conferito il dottorato in Filosofia e ottenne un incarico presso la stessa università, dove restò a insegnare fino alla sua morte, nel 1956. Non superò mai il grado di ricercatore, e pochi studenti, dopo aver frequentato i suoi corsi, serbarono di lui un ricordo nitido.”
Questo estratto non è un bignami della trama di Stoner fatta da qualche svogliato recensore: è l’incipit del romanzo. Buonsenso vorrebbe che un incipit in qualche modo non riveli completamente la storia del libro: John Williams rimanda al mittente il buonsenso e in queste poche righe di testo spoilera sfacciatamente l’intera vita di William Stoner, un everyman privo di particolari qualità.
Stoner nasce nel 1891 in una fattoria del Missouri, muore sempre nei dintorni a sessantacinque anni, dopo averne passati quaranta in un matrimonio triste con una donna che non lo ama, aver dovuto rinunciare a un amore sbocciato troppo tardi e concluso bruscamente, con pochissime amicizie (solo due) e una dedizione al lavoro contrastata dal suo grande nemico e capodipartimento, Hollis Lomax, che lo odia per ragioni poco chiare e meschinamente cerca di rendergli la vita accademica un inferno. Muore. Viene dimenticato. Tutto qua, o forse c’è molto altro di nascosto nella scrittura nitida e pulita di questo romanzo che riesce in un miracolo: rendere una vita qualunque qualcosa di incommensurabile, unico e distinto. Il cognome, Stoner, rassomiglia a stone, e c’è quasi una facoltà minerale in quest’uomo, una sorta di immobilismo (non si sposta mai dai dintorni del suo luogo di nascita), di inscalfibilità anche alle brutture di una vita spesso crudele a cui resiste in maniera stoica, senza abbandonare il carattere docile che gli è proprio. Queste caratteristiche Stoner le custodisce per tutta la vita occultandole agli occhi di tutti, forse anche ai suoi. D’altra parte, come recita un proverbio: il luogo migliore dove nascondere una foglia è la foresta.
E il lettore? Il lettore non può smettere di leggere e si chiede anche come mai tutto ciò lo interessi. Forse scopre qualcosa che pensava di aver dimenticato: il valore della semplicità. Come nel bellissimo film di Jim Jarmusch “Paterson”, che pure con la sua poesia minimalista – che si rifà a William Carlos Williams – esalta la qualità delle piccole cose, come le “Note del guanciale” di Sei Shonagon, la dama di corte giapponese dell’imperatrice Sadako vissuta nel X secolo, un fil rouge lega le esigenze di civiltà tanto lontane nel tempo e nello spazio ma che, raggiunto il massimo splendore imperiale e di possibilità materiali, in alcune nicchie scelte trovano i loro campioni di sensibilità capaci di osservare i dettagli più banali per illuminarli in una luce nuova: i fili di seta, la pioggia, il miagolio di un gatto, un fiore lasciato in un libro e ritrovato dopo anni, il libro stesso… La vita di un professore americano che insegna letteratura.
In qualche modo siamo terrorizzati dalla mediocrità: che si tratti in antichità dell’eroe capace di compiere grandi imprese, o dell’esigenza nella società contemporanea di primeggiare in ogni ambito con una competitività feroce e cannibale, ci angoscia l’idea di vivere una vita come tante, priva di eventi riconosciuti dagli altri come interessanti. Il grigiore è il tono di questa mediocrità, la piattezza del deserto il suo luogo, il silenzio la sua musica. Stoner ci riporta con i piedi per terra e ci dice che non è una tragedia: anche una vita imperfetta, semplice e con le sue meschinità, una vita grigia insomma, può nascondere un senso di meraviglia. Questo vale anche per la letteratura, di solito considerata il luogo privilegiato delle storie speciali con personaggi eccezionali: Stoner è “l’anti Gatsby“, un accademico privo di ogni qualità.
Nel 1973 il grande scrittore polacco Stanislaw Lem scrive “Vuoto Assoluto”: una raccolta fittizia di recensioni a libri mai scritti. Tra questi c’è “Do yourself a book”, un esperimento fatto per finalità di marketing in cui l’acquirente ha la possibilità di modellare, grazie a delle strisce di carta, un romanzo fai-da-te composto da classici (i romanzi usati sono privi di diritti d’autore: quindi Balzac, Dickens, Dostoevskij, Tolstoj e compagnia). Il recensore nota come la critica fosse scandalizzata dalla possibile immoralità di tale operazione: lettori pervertiti avrebbero potuto ricombinare le strisce in modo tale da rendere un dialogo innocuo di Dickens con dei sottotesti incestuosi, e chissà quali altre schifezze. In realtà, chiosa Lem, l’iniziativa è un flop: perché i vari Rastignac, Svidrigajlov, Vautrin, Raskolnikov sono famosi solo per quei pochi accademici e teste d’uovo, ma “per la stragrande maggioranza della gente questi personaggi, privi d’ogni stabile valore simbolico, sia questo la nobiltà d’animo o una diabolica dissolutezza, non hanno alcun interesse, né perverso né d’altro genere. Sono perfettamente neutri. E quindi non interessano a nessuno”.
Stoner è la conferma che in fondo la letteratura migliore è bella perché non parla di nulla di eccezionale. Ma a dispetto del mondo privo di lettori che Lem presagiva qualcosa ancora resiste – i motivi restano invece un mistero.
Nicola Laurenza