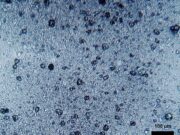La Francia attraversa una delle fasi più delicate della sua storia politica recente. La caduta del governo di François Bayrou, sfiduciato dall’Assemblea Nazionale, ha certificato non soltanto la fragilità dell’esecutivo guidato dal centrista vicino a Emmanuel Macron, ma anche l’erosione profonda del modello istituzionale della Quinta Repubblica. Un sistema che, nato nel 1958 per garantire stabilità, oggi sembra sempre più ostaggio di frammentazione parlamentare, conflitto sociale e leadership presidenziale indebolita.
Il voto di sfiducia era ampiamente previsto: Bayrou aveva scelto di sottoporsi alla prova parlamentare come ultimo tentativo per far approvare una legge di bilancio estremamente impopolare, basata su tagli alla spesa sociale e su misure di austerità che hanno scatenato la protesta di sindacati e opinione pubblica. L’esito è stato schiacciante: 364 voti contrari contro 194 favorevoli, con il governo costretto alle dimissioni. È il terzo esecutivo a cadere in poco più di un anno, dopo Gabriel Attal e Michel Barnier, segno che la Francia ha smarrito la solidità che aveva distinto per decenni la sua vita istituzionale.
Il contesto economico rende ancora più drammatica la crisi politica. Il debito pubblico ha superato il 113% del PIL, il deficit si aggira sul 5,8% e gli investitori internazionali chiedono interessi sempre più alti per finanziare i titoli francesi. Una situazione che avvicina la Francia ai livelli di paesi come l’Italia e la Grecia, rompendo un tabù storico: Parigi non è più considerata automaticamente un porto sicuro della stabilità europea.
Macron, Bayrou e il fallimento della stabilità francese
La caduta di Bayrou rappresenta un colpo diretto per Emmanuel Macron, che aveva scelto l’ex ministro centrista come figura di garanzia per tenere insieme un parlamento frammentato e polarizzato. Ma la sua strategia si è rivelata un boomerang. Invece di dialogare con i vincitori delle ultime elezioni legislative, in particolare i socialisti del Nuovo Fronte Popolare, Macron ha preferito puntare su governi di minoranza, contando sul sostegno esterno e occasionale dei Républicains e persino del Rassemblement National.
Il risultato è stato devastante: due governi caduti in meno di dodici mesi e una crescente percezione di instabilità. La scelta di Bayrou come primo ministro, presentata come mossa di equilibrio, ha finito per alienare le forze di sinistra e per rafforzare la narrativa dell’estrema destra. Marine Le Pen ha potuto presentarsi come l’unica alternativa credibile a un presidente debole, incapace di garantire la governabilità.
Dal punto di vista economico, le misure proposte da Bayrou hanno esasperato la tensione sociale. Il congelamento dell’indicizzazione delle pensioni e dei sussidi di disoccupazione, la proposta di abolire festività nazionali come il Lunedì di Pasqua e l’8 maggio, e soprattutto i tagli ai capitoli fondamentali del welfare hanno fatto esplodere la protesta. La Francia è storicamente legata a un modello di protezione sociale tra i più generosi d’Europa: toccare questo nervo scoperto ha significato accendere una miccia pronta a esplodere.
Sul piano politico-istituzionale, la vicenda Bayrou segna un passaggio cruciale per la Quinta Repubblica. Il meccanismo iper-presidenzialista, pensato da De Gaulle per superare la fragilità della Quarta Repubblica, mostra oggi tutti i suoi limiti. Senza una maggioranza solida, il presidente è costretto a governi di minoranza che non riescono a durare, mentre il parlamento diventa terreno di scontro tra opposizioni inconciliabili. Macron, che nel 2017 si presentava come il leader del rinnovamento, appare ora come il garante di un sistema logoro, incapace di riformarsi e sempre più distante dalla società civile.
La caduta del governo Bayrou è quindi molto più di una crisi contingente: è il sintomo di una crisi sistemica, in cui il modello politico francese non riesce più a garantire quella stabilità che lo aveva reso un’eccezione in Europa.
La crisi della Quinta Repubblica e l’ascesa dei nuovi populismi
La crisi politica in Francia non si esaurisce con le dimissioni di Bayrou. Essa si inserisce in un quadro più ampio di erosione della fiducia nelle istituzioni e di crescente radicalizzazione dell’elettorato. La Quinta Repubblica, costruita per garantire governi forti e continuità presidenziale, si trova ora stretta tra la polarizzazione delle forze politiche e la pressione sociale di un Paese sempre più diviso.
Marine Le Pen e il suo Rassemblement National sono i principali beneficiari di questa situazione. Nonostante la condanna che le impedisce di candidarsi alle prossime elezioni legislative, il partito di estrema destra continua a crescere nei sondaggi, alimentato dal malcontento verso Macron e dalla percezione che le élite centriste non siano in grado di gestire il debito, il deficit e la crisi del welfare. Jordan Bardella, erede politico designato, appare pronto a capitalizzare la caduta del governo, proponendo una visione radicale che combina nazionalismo economico e retorica anti-immigrazione.
Sul fronte opposto, Jean-Luc Mélenchon e La France Insoumise continuano a esercitare una forte attrazione sull’elettorato di sinistra, ma faticano a trasformare questa spinta in una coalizione stabile e credibile. I socialisti, pur rafforzati alle ultime elezioni europee e legislative, restano divisi sul rapporto con Macron e sulla possibilità di costruire un’alternativa realmente competitiva.
Il risultato è un sistema politico paralizzato: da una parte un presidente impopolare e prigioniero delle sue scelte, dall’altra opposizioni radicalizzate che non riescono a esprimere un progetto di governo condiviso. In questo vuoto cresce l’instabilità, che si traduce in sfiducia dei mercati, aumento dei tassi d’interesse e rischio di contagio per l’intera area euro.
La Quinta Repubblica, nata per superare l’instabilità cronica della Francia, rischia così di ripiombare nello stesso incubo che aveva motivato la sua creazione. Non è un caso che sempre più voci invochino una riforma costituzionale verso una Sesta Repubblica, capace di riequilibrare i poteri e di restituire al parlamento un ruolo più incisivo. Ma, in un contesto polarizzato, il rischio è che il cambiamento arrivi non da una riforma condivisa, ma da una rottura traumatica.
La caduta del governo Bayrou rappresenta un punto di svolta per la politica francese. Non si tratta di un episodio isolato, ma del terzo in poco più di un anno, segno che la Francia vive una crisi strutturale di governabilità. Emmanuel Macron, già duramente sconfitto alle europee e oggi ai minimi storici nei sondaggi, ha scelto di nominare Sébastien Lecornu, esponente del suo partito, come nuovo primo ministro. Una decisione che conferma la volontà dell’Eliseo di insistere sulla linea dei governi di minoranza, nonostante il destino fragile e precario che li ha già condannati nelle ultime esperienze. La Francia si trova così di fronte a un bivio irrisolto: continuare con esecutivi effimeri e instabili oppure rischiare elezioni anticipate che potrebbero consegnare il potere a uno degli esecutivi più di destra della sua storia repubblicana.
Macron sembra non aver ancora compreso l’ampiezza della crisi che ha di fronte. La caduta del governo Bayrou non è solo l’ennesimo inciampo parlamentare: è la certificazione del fallimento del macronismo, di quella pretesa di governare al centro rompendo gli schemi tradizionali. In realtà, l’area moderata si è svuotata, lasciando spazio solo a governi deboli, incapaci di reggere all’urto di un’Assemblea sempre più frammentata e polarizzata. Macron ha scavato al centro, erodendo il consenso degli altri partiti moderati e inglobando la spina dorsale dei partiti che per anni hanno retto il peso della Quinta Repubblica, accentrando consenso e potere ma facendo terra bruciata attorno a lui.
Il presidente ha costruito il suo successo iniziale proprio sulla promessa di superare i vecchi schemi destra-sinistra e di incarnare un centro dinamico, modernizzatore. Svuotando i partiti tradizionali senza creare cultura politica alternativa e di sostegno, ha trasformato il “macronismo” in un mero progetto personale, dipendente dal carisma, dal consenso e dalla figura del presidente. Il centro, in Francia, ormai, non esiste più. Governi fragili, alleanze instabili e un’Assemblea sempre più polarizzata. Ha conquistato il potere e lo ha accentrato, ma Macron ha anche impedito alla classe dirigente di rendersi autonoma, costruire le radici e soprattutto reggere la Quinta Repubblica oltre lui.
La nomina di Lecornu mostra la stessa miopia strategica: un gesto di continuità che, per quanto logico sia, dal suo punto di vista, non farà altro che acuire la crisi, rendendola ingestibile. Macron ha deciso di insistere sul breve respiro, ma così rischia di lasciare in eredità soltanto macerie istituzionali e un Paese ancora più ingovernabile.
Il nodo centrale resta la sostenibilità della Quinta Repubblica. Il modello iper-presidenzialista ha garantito per decenni stabilità e continuità, ma oggi mostra tutta la sua vulnerabilità di fronte a un sistema politico frammentato e a una società spaccata. L’ascesa dei populismi di destra e di sinistra, il malcontento sociale per i tagli al welfare e il peso del debito pubblico contribuiscono a rendere la Francia un Paese sempre più ingovernabile.
In questa cornice, la caduta di Bayrou non è soltanto la fine di un governo: è la rappresentazione plastica del declino del macronismo e della crisi di un’intera architettura istituzionale. La Quinta Repubblica, pensata per superare le fragilità della politica francese, rischia di collassare sotto il peso delle sue stesse rigidità. E il futuro dell’Unione Europea dipenderà anche dalla capacità – o dall’incapacità – di Parigi di ritrovare un equilibrio politico stabile e credibile.
Donatello D’Andrea