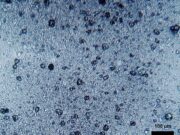I temuti dazi di Donald Trump sono arrivati. In una surreale conferenza stampa, con tanto di cartellone esplicativo, il Presidente degli Stati Uniti ha dato il via al più grande e ampio aumento dei dazi sulle merci straniere da quasi un secolo. La decisione è arrivata dopo un lungo periodo di minacce e insulti, soprattutto ai danni dell’Unione Europea, Canada e Messico, con il chiaro obiettivo di riequilibrare la bilancia commerciale americana, da sempre, secondo il capo dello stato americano, a favore degli altri stati e a sfavore degli USA. In poche parole, il Tycoon usa i dazi per difendere l’industria nazionale dalla concorrenza straniera. Almeno in teoria.
Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Da mercoledì le borse mondiali aprono e chiudono in perdita, con percentuali che non si vedevano da anni (come quella di Milano, che ha perso il 7%) e numerosi Paesi, come la Cina – che ha fatto ricorso al WTO – hanno deciso di reagire con dei contro-dazi. La Commissione Europea, dal canto suo, sta pensando a delle misure da contrapporre sulle merci americane, mentre i singoli stati vengono invitati dal Presidente americano alla Casa Bianca, per discutere nel merito.
Quanto si sta consumando, è il preludio di una guerra commerciale, inaugurata proprio da chi non ti aspetti: dagli Stati Uniti nei confronti degli alleati di sempre, gli europei. La rottura di un patto pluridecennale basato su un’amicizia innanzitutto commerciale, poi politica e infine militare. Lo strumento usato da Donald Trump, però, non ha finalità economiche, come si potrebbe erroneamente pensare: la sua è una mossa politica studiata a tavolino e coerente con la sua “nuova-vecchia” concezione dei rapporti fra gli Stati, in particolare fra gli USA e il resto del mondo.
I dazi sono innanzitutto uno strumento di pressione in politica estera, come dimostra il congelamento al 10%, contrariamente a quanto previsto dagli annunci iniziali, per 90 giorni nei confronti di tutti quei Paesi che non hanno immediatamente applicato contromisure e si sono mostrati disponibili a trattare. Una dottrina che il Tycoon ha utilizzato durante il suo primo mandato presidenziale e che ha riproposto in occasione del suo incontro con il Presidente Zelensky. Nonostante ciò, è lapalissiano che i dazi produrranno degli effetti economici a lungo termine, sia per il ruolo commerciale degli Stati Uniti nel mondo, sia nelle modalità con cui sono stati calcolati e concepiti.
Cosa sono i dazi
I dazi sono un’imposta che si applica sulle merci in arrivo da uno stato straniero e si esprimono in valore percentuale del prezzo di vendita di un prodotto e ricadono su chi importa, quindi sul Paese che compra le merci, che li paga alla dogana del Paese in cui fanno ingresso. Ad esempio, il dazio verso la Cina, varrà il 34%. Questo significa che su un bene che costa 20mila dollari, il fornitore americano che lo acquista pagherà una tassa di 6.800 dollari. In totale, portare questo bene negli Stati Uniti costerà 26.800 dollari escluse altre spese e necessariamente dovrà venderlo ad una cifra non inferiore per non perderci. Quindi, solitamente, questi costi aggiuntivi vengono scaricati sui consumatori, che lo pagano a prezzo maggiorato.
L’idea alla base dei dazi è abbastanza semplice. Un prodotto straniero viene a costare di più, quindi i consumatori sceglieranno di comprare merce nazionale. Ma applicare una soluzione semplice ad un problema complesso è quasi sempre la scelta sbagliata: le preferenze dei consumatori, tanto per dirne una, non sono influenzate soltanto dal prezzo. Più un prodotto è conosciuto, apprezzato e riconosciuto, più i consumatori lo desidereranno e non sempre il prezzo rappresenta un ostacolo. Inoltre, può anche succedere che il fornitore decida di abbassare il prezzo all’esportazione, assorbendo il dazio per non perdere fette di mercato. In tal caso non sarebbero i consumatori a pagarlo bensì il produttore. Un’ipotesi remota, ma applicabile ai grandi marchi, ad esempio, che possono permettersi di assorbire tale imposta.
I dazi, però incidono anche sulla distribuzione della ricchezza, in quanto agiscono sui prezzi, facendo aumentare le divisioni e quindi il costo della vita. In genere le misure protezionistiche, che quasi tutte le teorie economiche condannano, potrebbero funzionare soltanto in previsione di un aumento della produzione nazionale di un prodotto, favorendo l’occupazione di settore. Ma affinché si producano effetti positivi, è necessario che si intervenga sui settori più colpiti dalla concorrenza internazionale, in grado di coinvolgere lavoratori poco qualificati. E non è questo il caso.
I dazi, però, portano nelle casse dello stato grandi guadagni, grazie alle dogane. Alcuni citano, a sproposito, il caso dell’Unione Europea asserendo che il continente sia il primo a imporre dazi agli altri. In particolare, nei confronti della Cina. A dire il vero, il dazio nei confronti della merce cinese esiste, nel settore della automobili elettriche nello specifico, ma solamente perché Pechino elargisce maxi-sussidi alle proprie aziende, quindi al Paese esportatore. Sono i cosiddetti “dazi compensativi“, istituiti ai sensi delle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e volti a neutralizzare gli effetti negativi delle sovvenzioni.
Dall’inizio degli anni Novanta, comunque, la comunità internazionale ha cercato di limitare le misure protezionistiche quali i dazi che, in un mondo globalizzato e che ha accettato implicitamente la “clausola della nazione più favorita“, non trovano senso di esistere. Le eccezioni ci sono, ovviamente, ed è il caso di quelli compensativi ma anche quelli nei confronti di settori strategici per i Paesi, come la tecnologia. Anche lo stesso Biden, durante la sua amministrazione, ha imposto una tassazione aggiuntiva nei confronti di Pechino, volto a limitare il rapido avanzamento tecnologico del governo cinese. Il caso di Donald Trump, però, è diverso. Da un lato c’è la volontà di tutelare il mercato americano, dall’altro, però, c’è la chiara e inequivocabile intenzione di costringere gli altri a trattare e, di conseguenza, scendere a compromessi sfavorevoli con gli Stati Uniti.
La mossa politica di Trump
Studiati a tavolino, i dazi di Donald Trump nascondono, dunque, una limpida finalità politica. E questa emerge anche dal calcolo con cui sono stati concepiti. Come fanno notare in molti, i dazi non rispecchiano per niente il deficit commerciale americano e lo squilibrio nei confronti delle altre nazioni, anzi. Nel prospetto che ha presentato, il famoso “cartellone delle tariffe”, il Presidente ha definito la tassazione che, a suo dire, quel Paese applica agli Stati Uniti. Ad esempio ha detto che l’UE ha dei dazi al 39% verso gli Stati Uniti e per questo motivi “ne merita almeno la metà” (il 20% che è stato imposto, poi ritrattato al 10% per i prossimi 3 mesi).
Il calcolo per arrivare a questi numeri è stato esposto dal Dipartimento del Commercio poco dopo l’annuncio dei dazi: in sostanza si prende il deficit commerciale degli Stati Uniti verso un determinato paese (cioè quando gli Usa acquistano da un paese più di quanto vendono a quel paese), lo si divide per il totale delle importazioni americane (ovvero il valore complessivo dei beni che gli Usa acquistano da quel paese), e poi si dimezza il risultato.
Il numero che viene fuori è la famosa “tariffa” applicata agli americani, cioè la giustificazione alle imposizioni di dazi ad ogni Paese da parte di Washington. Peccato che tale formula comprenda, se completa, anche l’elasticità della domanda di importazioni, la quale misura quanto variano le importazioni al cambiare dei prezzi, e il coefficiente di trasmissione dei dazi, che indica quanta parte del dazio si trasferisce sui prezzi finali.
L’amministrazione Trump ha scelto un’elasticità pari a 4, superiore di due volte al valore indicati dai recenti studi sul tema, e un coefficiente di 0,25 (molto basso rispetto ai parametri storici). Tali scelte appaiono calibrate per ottenere risultati decisi tavolino e non riflettono decisamente la realtà economica. A dirlo, non di certo il primo che viene, bensì il Financial Times. Ma l’economia e il commercio, come anticipato, non c’entrano nulla. I dazi di Trump parlano politichese.
Gli squilibri commerciali, secondo le teorie economiche moderne, sono il risultato naturale differenze strutturali fra le economie, nella maggior parte dei casi. Ma qui Donald Trump ha trasformato la sua visione politica sul commercio e i rapporti internazionali in una formula matematica che parte dal presupposto che i singoli Paesi debbano sedersi a tavolino con gli americani per trattare condizioni a loro sfavorevoli per non inimicarsi “il grande fratello a stelle e strisce“. In una eventuale guerra commerciale, a dire il vero già in atto, i Paesi che subiscono i dazi avrebbero molto da perdere. E la reazione è stata quella sperata: Israele, ad esempio, ha deciso di trattare con Trump, l’UE ha minacciato ritorsioni ma non ha escluso il negoziato.
Missione compiuta? Dipende, perché gli effetti economici a lungo termine sarebbero sfavorevoli anche per gli americani stessi, non solo per gli europei e gli altri stati. Ecco perché i dazi di Trump sono una misura politica a breve termine e molto probabilmente nel mezzo ci saranno pause negoziali sulla scia del dividi et impera.
La reazione del mondo dimostra che, almeno per il momento, il Tycoon ha lanciato uno scacco matto, figlio di una concezione del mondo più politica che economica, nonostante l’evidenza dica che al timone degli Stati Uniti ci sia un imprenditore e non un politico. Una lezione da tenere a mente quando ci si approccia alle relazioni internazionali: fuori dagli schemi si fa politica, non economia.
Donatello D’Andrea