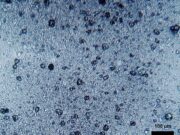La guerra tra Russia e Ucraina, ormai giunta al suo secondo anno, non è soltanto un conflitto armato alle porte dell’Unione Europea: è diventata, a tutti gli effetti, lo specchio deformante della crisi dell’atlantismo europeo. L’alleanza euro-atlantica, pilastro dell’ordine liberale del secondo dopoguerra, mostra segni di profondo affaticamento strategico, tanto nella capacità di mantenere coesione interna quanto nel saper offrire una risposta proattiva e coesa a una minaccia sistemica. La crisi non riguarda solo la tenuta militare o il supporto materiale a Kyiv: riguarda il senso stesso dell’integrazione politica e del progetto europeo nel contesto di un ordine globale sempre più frammentato.
Dal febbraio 2022, l’Europa si è mossa lungo una linea ambigua, oscillando tra una retorica della fermezza nei confronti di Mosca e una prudenza diplomatica sempre più evidente. Mentre gli Stati Uniti hanno assunto da subito una postura di leadership operativa, dettando tempi, condizioni e linguaggio della risposta occidentale, molte capitali europee hanno dato prova di esitazioni, divergenze e calcoli interni. Berlino ha oscillato tra la necessità di sostenere Kyiv e il timore di un’escalation energetica; Parigi ha tentato una mediazione parallela, spesso marginalizzata; Roma si è attestata su una linea filo-atlantica ma con poca iniziativa autonoma.
La guerra russo-ucraina ha così messo a nudo l’incapacità dell’Unione Europea di trasformare il proprio soft power economico e normativo in una postura geopolitica incisiva. L’atlantismo, un tempo collante ideologico e operativo, si è trasformato in una delega strutturale alla leadership statunitense, con il risultato di rendere l’Europa spettatrice più che protagonista. Di fronte all’aggressività russa e alla capacità della propaganda del Cremlino di polarizzare le opinioni pubbliche, l’Europa sembra aver smarrito il vocabolario per parlare con autorevolezza ai propri cittadini e ai propri partner globali. La crisi in Ucraina è dunque anche una crisi di narrazione: quella di un continente che promette pace e stabilità, ma non riesce a garantirle.
I piani di Putin e gli obiettivi della Russia
Il teatrale riconoscimento dell’indipendenza del Donbass da parte di Putin, e le conseguenti operazioni militari, potrebbero cambiare radicalmente la storia del conflitto tra Russia e Ucraina. Per la prima volta dalla caduta del muro di Berlino è il Presidente russo ad avere l’iniziativa e, apparentemente, il suo obiettivo principale è quello di calcare la mano fin quando gli è possibile. Tra gli obiettivi di Mosca non c’è soltanto quello di impedire che l’Ucraina possa entrare nella Nato. Quella russa è anche un’azione volta a testare la reale compattezza del fronte occidentale. Le sanzioni penalizzeranno soprattutto gli europei e Putin spera che ciò possa contribuire a destabilizzare la Nato e la proiezione americana nel continente.

Un altro obiettivo è quello di ridiscutere l’assetto generale dell’Europa. Dopo il 1989 la Nato si è eccessivamente allargata ad Est, inglobando nell’alleanza ex membri del Patto di Varsavia e anche ex repubbliche sovietiche, stringendo la Russia in una morsa. La claustrofobia russa è giustificata dalla presenza massiccia di basi Nato in Europa e dagli armamenti americani posizionati in direzione di Mosca. Se la madrepatria russa e l’area di influenza di Washington durante la Guerra fredda distavano migliaia di km ora, dopo l’ingresso massiccio dell’ex blocco sovietico nella Nato, si toccano pericolosamente. La Russia si sente in pericolo, dato che le armi americane distavano circa 1500 km (da Berlino Ovest) e ora sono posizionate a meno di 500 km. Putin vuole dunque ridisegnare le aree di influenza delle due potenze che hanno tra le mani il destino dell’Europa.

Nelle ultime ore anche la Duma, il Parlamento russo, ha approvato la decisione del Presidente. Una formalità, dato che è stato lo stesso parlamento a presentare la proposta di riconoscimento qualche giorno fa. Si pone, tuttavia, un problema. Le due repubbliche non hanno il controllo dell’intera regione. I separatisti si limitano ad amministrare solo una minima parte del Donbass. In realtà tale condizione rappresenta soltanto un problema per l’Ucraina: Putin ha espressamente sottolineato che i confini delle due repubbliche sono gli stessi di ”quando facevano parte dell’Ucraina”. Così facendo le probabilità che gli eserciti si scontrassero sono aumentate precipitosamente e hanno offerto a Putin l’opportunità di intervenire in nome dell’alleanza militare esistente tra la Russia e i separatisti.
L’Unione Europea segue gli Stati Uniti
Nelle ultime ore sia gli Stati Uniti che l’Unione Europea, in risposta all’escalation della crisi tra Russia e Ucraina, hanno approvato delle sanzioni che colpiranno l’intera Duma, numerosi oligarchi russi e tutti i soggetti che operano in vari settori, dall’economia all’informazione, accusati di aver contribuito a danneggiare la sovranità dell’Ucraina. A sostenere la soluzione delle sanzioni sono soprattutto gli Stati Uniti, i quali considerano quello europeo un fronte minore rispetto a quello dell’Asia-Pacifico, ma lavorano comunque affinché Russia ed Europa restino due entità distinte e conflittuali. Le ritorsioni economiche, però, rischierebbero di colpire anche quel gas di cui l’UE non può fare a meno.
Nei giorni scorsi, infatti, è stato lo stesso Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, ad auspicare che le eventuali sanzioni non toccassero il settore energetico. D’altronde l’Italia dipende fortemente dalle forniture di gas naturale provenienti dalla Russia. Nel 2020, il 43,3% del gas naturale importato dall’Italia proveniva da Mosca. Ma Roma non è l’unica ad essere vulnerabile. Stando a fonti dell’ISPI, l’Italia, assieme ad altri 10 Paesi, avrebbe inviato un documento informale alla Commissione Europea per escludere l’energia dalle possibili sanzioni a Mosca.
Le prime crepe all’interno dell’alleanza occidentale sono evidenti, così come è evidente l’influenza americana nelle decisioni di politica estera delle cancellerie europee. Una di queste è la sospensione dell’autorizzazione del Nord Stream 2, la seconda conduttura dell’omonimo gasdotto che, lungo circa un migliaio di km, collegherebbe direttamente la Russia alla Germania. Il gasdotto non è mai piaciuto agli americani, i quali hanno fatto pressione al governo tedesco di ritardarne il più possibile l’entrata in funzione. Washington lo considera l’ennesima arma geopolitica di Putin per tenere sotto scacco l’Unione Europea. Anche Mosca faceva pressioni, ovviamente affinché entrasse in funzione il prima possibile. Alcuni interpretano la mossa di Scholz come puramente strategica: se il gasdotto fosse entrato nelle sanzioni europee, difficilmente ne sarebbe uscito, dato che l’entrata in funzione non sarebbe stata più questione del solo governo tedesco.
Crisi Russia-Ucraina: lo stallo
L’approvazione all’unanimità delle sanzioni in seno alla riunione straordinaria dei ministri è, comunque, una risposta puramente retorica e obbligata. Le divergenze esistono. Da un lato c’è chi vuole colpire duro (USA e Regno Unito), dall’altro chi invece non vuole strafare con le sanzioni economiche (Italia, Francia, Germania), per la convinzione che la soluzione diplomatica sia ancora la strada maestra. Con il peggiorare della situazione, i Paesi europei hanno risposto convocando i rispettivi consigli militari, mentre nel pomeriggio ci saranno le riunioni del G7 e un Consiglio Europeo straordinario. L’obiettivo è quello di fare ciò che non è stato fatto fino ad ora: elaborare una linea comune.
Il presidente americano Joe Biden, comunque, ha escluso qualsiasi intervento militare. Nonostante ciò, ha deciso di spostare alcuni soldati americani presenti in Europa centromeridionale nei paesi baltici per tutelare gli interessi dell’alleanza. La situazione resta, ovviamente, tesa, con l’Ucraina ormai bersagliata dalle truppe russe nel Donbass e in Bielorussia, mentre l’Occidente assiste attonito a ciò che, inutilmente, ha tentato di evitare fino all’ultimo: un conflitto.
Putin, dal canto suo, sta usando l’intervento armato per ”de-militarizzare e de-nazificare” l’Ucraina. Cosa significa? Putin vorrebbe sfaldarla e renderla inoffensiva, magari preparando il terreno per insediare a Kiev un esecutivo filo-russo che ponga fine alle aspirazioni occidentali dell’Ucraina. Poi ci sono le repubbliche separatiste, che il Presidente preferirebbe annettere senza troppe perdite: attaccare su larga scala, colpendo in più punti, confonderà le forze ucraine e le farà disperdere.
Inoltre alla base delle certezze di Putin c’è il fatto che l’Occidente stia giocando a carte scoperte: Bruxelles e Washington hanno risposto al riconoscimento del Donbass con sanzioni prevedibilmente effimere e poco efficaci, che puntano più a non danneggiare l’Europa che a far male la Russia. Ora con l’invasione, ci si aspetta che queste si inaspriscano. Le conseguenze sono note: controsanzioni sul gas e danneggiamento dei rapporti commerciali con i Paesi UE.
La crisi tra Russia e Ucraina ha riconsegnato agli Stati Uniti il nemico di sempre, quindi potrebbe addirittura favorire il nazionalismo interno e di riflesso chi si ritrova a contrastarlo, cioè Biden. L’Europa si lecca le ferite. Gli stati europei hanno cercato di risolvere la crisi diplomaticamente con risultati disastrosi – basti considerare l’impegno profuso da Macron e la delusione del suo ministro degli Esteri una volta aggiornato circa gli ultimi accadimenti, come se fosse sorpreso dall’escalation. Alla fine, l’Unione Europea si è accodata ai desiderata americani a causa della sua strutturale debolezza come attore internazionale. La risoluzione della crisi Russia-Ucraina è perciò ancora molto lontana.
Donatello D’Andrea