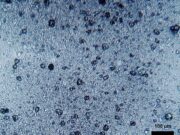Il conflitto tra Israele e Iran è esploso in una guerra aperta dopo anni di tensioni crescenti, cyberattacchi, sabotaggi e operazioni coperte. La miccia è stata accesa dai massicci bombardamenti israeliani su infrastrutture strategiche iraniane, incluse quelle legate al programma nucleare. Quello che da anni era un confronto indiretto, asimmetrico e spesso negato, è ora diventato una guerra dichiarata, con tutte le implicazioni che soltanto il Medio Oriente sa “regalare”.
Nel mezzo di questa escalation, l’ingresso degli Stati Uniti segna una svolta decisiva. Dopo una settimana di ambiguità e dichiarazioni contraddittorie, culminate nel discorso pubblico del presidente Trump, Washington ha deciso di colpire. Nella notte tra sabato e domenica, tre siti nucleari iraniani sono stati bombardati con bombe bunker-buster, nell’intento di degradare il potenziale nucleare iraniano e rilanciare una deterrenza credibile.
Le ragioni dietro l’azione americana sono molteplici. Da un lato, la preoccupazione per il programma nucleare iraniano, che dopo l’abbandono del JCPOA ha visto livelli di arricchimento dell’uranio fino al 60%, avvicinandosi pericolosamente alla soglia del materiale fissile per uso militare (90%). Dall’altro, la volontà politica di riposizionare gli Stati Uniti come attore centrale nel Medio Oriente, rafforzando la credibilità dissuasiva erosa negli ultimi anni. Infine, la pressione interna: Trump, in difficoltà politica sul fronte interno per la questione dazi, ha bisogno di consolidare la propria immagine come leader forte e risoluto. E lo fa attuando la sua classica strategia del bastone senza la carota.
Iran, Israele e la crisi degli equilibri regionali
Il conflitto tra Israele e Iran non è un fulmine a ciel sereno. Da anni si consuma una guerra a bassa intensità fatta di sabotaggi, attacchi cibernetici, operazioni sotto copertura e assassinii mirati. Ma negli ultimi mesi la frizione si è trasformata in conflitto aperto. Gli attacchi israeliani a infrastrutture strategiche iraniane, in particolare ai siti del programma nucleare e missilistico, hanno provocato una risposta diretta di Teheran, che ha bombardato città israeliane e attivato le proprie milizie alleate nella regione. La spirale di escalation è diventata incontrollabile, rompendo i consueti schemi di deterrenza che regolavano i rapporti tra i due Paesi.
Israele si muove secondo una dottrina consolidata di pre-emption, colpendo prima che una minaccia diventi operativa. È quanto avvenne con il reattore iracheno Osirak nel 1981 e con il sito siriano di Deir ez-Zor nel 2007. L’intervento contro l’Iran si colloca in questa stessa logica: prevenire l’acquisizione di una capacità nucleare militare che rappresenterebbe una minaccia esistenziale. La differenza è che, stavolta, l’Iran ha reagito apertamente, trascinando la regione in un conflitto dai contorni ancora indefiniti. La guerra Israele-Iran è ora un fatto, con implicazioni regionali e globali.
In questo contesto, l’ingresso degli Stati Uniti ha rappresentato una svolta decisiva. Dopo giorni di ambiguità strategica e dichiarazioni contraddittorie, la notte tra sabato e domenica ha visto Washington colpire tre siti nucleari iraniani – Fordo, Natanz e Isfahan – con bombe bunker-buster, capaci di penetrare strutture sotterranee. L’obiettivo dichiarato era rallentare il programma nucleare iraniano, non distruggerlo: un attacco limitato ma ad alta intensità, pensato per massimizzare l’effetto deterrente senza innescare una guerra totale.
La decisione, maturata dopo settimane di escalation, riflette l’intenzione americana di non lasciare a Israele l’onere dell’impantanarsi, ma anche di non impegnarsi in un conflitto prolungato. Il raid è stato presentato come “chirurgico” dalla Casa Bianca, un messaggio chiaro rivolto a Teheran: possiamo colpire duramente, ma non cerchiamo un’escalation. Allo stesso tempo, serve a Trump per mostrare leadership in un momento in cui la sua amministrazione è sotto pressione.
L’approccio dell’amministrazione Trump si distingue per l’assenza di ambiguità decisionale: si colpisce per trattare. Ma si tratta senza offrire concessioni. La dottrina comunicativa adottata da Donald Trump è coerente con la sua logica di potenza: bastone senza carota, un uso deliberato della forza per creare pressione, senza offrire pubblicamente un’alternativa diplomatica. La sua strategia non è indirizzata alla stabilità regionale quanto alla proiezione di forza e alla costruzione della propria immagine di leader risoluto. È una politica del rischio calcolato, dove il messaggio è più importante del risultato operativo: “possiamo colpire quando vogliamo, ma sceglieremo noi il momento e il livello dello scontro.”
Resta da capire se questa scelta produrrà l’effetto sperato. Al momento, la reazione popolare in Iran è contenuta. Non ci sono segnali di sollevazioni interne né di movimenti organizzati capaci di capitalizzare la crisi. Ma un attacco esterno può, come già accaduto in passato, rafforzare la retorica anti-occidentale del regime, consolidando il fronte interno invece di indebolirlo. Ed è qui che emerge l’ambiguità della posizione americana: vogliono davvero un regime change a Teheran? Oppure preferiscono mantenere in vita un nemico funzionale alla loro narrativa globale?
La risposta dipende anche da cosa vogliono gli israeliani. Per Tel Aviv, l’obiettivo è chiaro: impedire in ogni modo che l’Iran diventi una potenza nucleare. Per Washington, il punto è più sfumato. Non è detto che Israele e Stati Uniti abbiano la stessa visione strategica. Uno punta alla neutralizzazione, l’altro alla gestione. È una dissonanza che, se non affrontata, potrebbe trasformarsi in un elemento di instabilità.
Medio Oriente, Stati Uniti e l’illusione del disimpegno
L’intervento americano riporta gli Stati Uniti al centro del Medio Oriente in un momento in cui la priorità strategica dell’amministrazione era spostare il focus sull’Indo-Pacifico, contenere la Cina e rafforzare l’alleanza atlantica. Il ritorno nella polveriera mediorientale non era previsto e rischia di sottrarre risorse, tempo e attenzione da dossier considerati centrali per il futuro dell’egemonia statunitense.
Per la Cina, tutto questo rappresenta un’opportunità. Mentre gli americani sono costretti a tornare nel quadrante medio-orientale, Pechino può rafforzare la propria influenza economica e diplomatica, senza competizione diretta. Allo stesso modo, la Russia – benché assorbita dalla crisi in Ucraina – osserva con attenzione la possibilità di capitalizzare sul disordine occidentale.
Il Medio Oriente, da parte sua, resta lo specchio delle fragilità globali. Ogni crisi lì produce effetti sistemici: sull’energia, sulla sicurezza, sulla percezione del potere occidentale. Gli Stati Uniti, pur riluttanti, si ritrovano di nuovo incastrati in un’area che speravano di lasciare alleati e attori locali. Ma se Washington si ritira troppo in fretta, il vuoto viene colmato da altri: potenze revisioniste, attori non statali, movimenti transnazionali. E questa volta, uscire potrebbe costare più che restare.
L’attacco statunitense contro l’Iran segna un passaggio decisivo, ma non risolutivo. È una mossa strategica per guadagnare tempo, un’azione calibrata per fermare – o almeno rallentare – un programma nucleare che rappresenta una minaccia percepita non solo da Israele, ma da tutto l’asse occidentale. Tuttavia, se non accompagnata da una visione politica di lungo termine, rischia di lasciare tutto com’era: instabile, polarizzato. L’intervento americano nella guerra tra Israele e Iran dimostra quanto sia fragile l’idea di un disimpegno strategico degli Stati Uniti dal Medio Oriente. Nonostante le reiterate dichiarazioni delle ultime amministrazioni – da Obama a Biden, passando per lo stesso Trump – secondo cui l’asse della politica estera americana si sarebbe spostato verso l’Indo-Pacifico, la realtà geopolitica si incarica puntualmente di smentirle.
Proprio perché gli Stati Uniti sono già profondamente impegnati su altri fronti strategici, l’amministrazione Trump ha tenuto a sottolineare che l’attacco ai siti nucleari iraniani è stato un intervento mirato e isolato, non l’inizio di una nuova guerra. Il recente annuncio di un cessate il fuoco sembra andare in questa direzione.
Il Medio Oriente resta un nodo strategico irrinunciabile, sia per il peso energetico, sia per la centralità nello scontro tra potenze regionali e globali. Lasciare mano libera a Teheran, o permettere un’escalation fuori controllo tra Iran e Israele, avrebbe effetti devastanti su mercati, alleanze e sicurezza internazionale. L’illusione del disimpegno si infrange sul fatto che gli Stati Uniti, volenti o nolenti, sono ancora i garanti dell’equilibrio globale. E quando l’equilibrio salta, sono costretti a intervenire.
Il problema è che ogni intervento riduce la capacità americana di agire altrove. In un momento storico in cui la sfida con la Cina si fa sempre più pressante e la situazione in Europa orientale è tutt’altro che risolta, Washington rischia di disperdere risorse e attenzione in uno scenario che non voleva più essere centrale. Questo comporta un costo strategico elevato: ogni giorno passato a contenere Teheran è un giorno sottratto al contenimento di Pechino.
Ma l’alternativa qual è? Lasciare che siano attori come Russia e Cina a riempire il vuoto lasciato dagli Stati Uniti? È uno scenario che preoccupa il Pentagono, ma che Trump sembra pronto ad accettare, a patto di poter rivendicare successi tattici. In questo senso, l’intervento in Iran è una vittoria di breve periodo, ma non una strategia di lungo termine. La vera questione resta aperta: gli Stati Uniti possono ancora permettersi il lusso di scegliere dove impegnarsi?
L’escalation tra Israele e Iran, con l’intervento degli Stati Uniti, segna una nuova fase nella lunga crisi mediorientale. Più che una soluzione, sembra l’inizio di una nuova era di instabilità, in cui ogni attore gioca partite diverse con obiettivi solo parzialmente convergenti. Gli americani vogliono deterrenza, gli israeliani neutralizzazione, gli iraniani sopravvivenza e legittimazione.
Nel mezzo, resta il rischio di una guerra lunga, ibrida, frammentata e imprevedibile. E la consapevolezza che nessuna superpotenza può davvero disimpegnarsi dal Medio Oriente, se vuole conservare la leadership globale.
Donatello D’Andrea