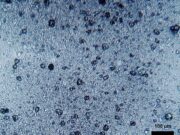Washington DC, febbraio 2025. Donald Trump, il vicepresidente Vance e il Presidente ucraino Zelensky si incontrano per discutere i termini della pace in Ucraina, per porre fine ad un conflitto che da circa tre anni imperversa in Europa e nel mondo, con conseguenze sociali, economiche e politiche che hanno ripercussioni soprattutto in Occidente. I toni, sin da subito, sono molto accesi. Il Tycoon e il suo vice insistono nell’imporre il loro punto di vista all’ucraino, il quale non ci sta e risponde con le sue argomentazioni. Volano stracci, parole pesanti, accuse al limite dell’incidente diplomatico.
L’incontro si rivela un disastro, con Trump che minaccia conseguenze e il Presidente ucraino che lascia lo studio ovale e non tiene la conferenza stampa congiunta. Gli Stati Uniti interrompono l’invio di armi e soprattutto smettono di condividere i dati rilevati dall’intelligence, quei famosi satelliti a disposizione di Elon Musk che contribuiscono alla superiorità militare americana nel mondo. La Russia incassa qualche vittoria e mette in difficoltà l’esercito ucraino. Il Presidente Zelensky ci ripensa e riprende il dialogo con Trump: un trionfo diplomatico per il Tycoon. Di diplomazia ce n’è poca, a dire il vero, ma a Trump delle strette di mano poco importa. Il suo obiettivo è quello di tornare ad una logica pre-statale e cioè ad un’epoca storica in cui erano gli imperi a dettare l’agenda mondiale.
La logica imperiale di Donald Trump è rintracciabile in ogni sua azione, anche nei dazi. Dietro, c’è una profonda logica politica e non solo economica. Il Dipartimento del Commercio ha pubblicato una formula, quella con cui sono state calcolate le imposizioni fiscali ma è nello Studio Ovale che il tutto si è deciso e il via-vai dalla Casa Bianca dei capi di stato e di governo, alla ricerca di uno “sconto”, è il vero risultato che il Tycoon vuole rivendicare. Un braccio di ferro che si consuma sulle spalle dei contribuenti e che si pone il fine di indebolire i competitor, riportandoli con la forza sotto l’ala protettiva degli Stati Uniti ma questa volta non in base ad un accordo pacifico o ad un’alleanza decennale bensì pagando e sottomettendosi.
Un’ambizione, quella di Trump, che si sposa perfettamente con lo scenario internazionale che il mondo sta attraversando. Dall’imperialismo russo al neo-colonialismo economico cinese, passando per la debolezza europea e il conseguente riarmo del continente. Si respira aria di tensione e la reazione a catena, in Occidente, è guidata proprio dagli Stati Uniti. Gli imperi sono tornati o non se ne sono mai andati?
Chi nasce impero, muore impero
Una regola non scritta della geopolitica: chi nasce impero, muore impero. Gli Stati Uniti lo sono, a pieno titolo, e per oltre un secolo hanno dettato l’agenda mondiale, declinato le relazioni internazionali secondo i loro desiderata e contro i loro avversari. C’è chi dice che l’impero americano sia in declino e, in teoria, ciò farebbe parte di un ciclo. Un ciclo di ascesa e indebolimento che tutti gli imperi attraversano. Molti, prima di lasciare lo scettro, combattono con le unghie e con i denti. Può essere il caso, questo, dell’impero americano?
Se nei rapporti con gli altri, l’atteggiamento di Trump è quello di un imperatore, nelle cause, concause e conseguenze del presunto declino americano ci sarebbe molto da dire e non tutto dipende dal caso di specie, cioè dalle azioni dell’attuale inquilino della Casa Bianca.
Molti fanno risalire i primi segnali di cedimento all’inizio degli anni Duemila, con le guerre in Iraq e in Afghanistan, le quali hanno eroso l’immagine statunitense nel mondo e soprattutto si sono risolte in dolorose sconfitte militari. Gli americani hanno sempre, o quasi, basato la loro diplomazia sull’utilizzo della forza, riuscendo a trovare un cavillo o una giustificazione alle loro azioni o, perlomeno, riuscendo con maestria a conquistare il consenso dell’opinione pubblica. Il fallimento delle operazioni – o meglio, il non riuscire a governarne le conseguenze – ha inciso sicuramente sull’influenza politica degli Stati Uniti nel mondo e anche su quella nei confronti di Stati amici come il Pakistan, che all’epoca delle operazioni militari era diventato un presidio importante da cui partivano le incursioni in terra afgana. Le alleanze con questi Paesi hanno garantito l’accesso americano a diverse zone del pianeta.
L’ascesa di potenze regionali, come la Cina e la Turchia, poi, ha eroso l’influenza americana in zone di interesse strategico fondamentale come l’Indo-Pacifico e il Medio Oriente. Questi due Paesi, in particolare, hanno investito su un crescente nazionalismo che si fonda, in parte, anche su sull’insofferenza nei confronti della leadership americana. La stessa narrazione che Mosca e Pechino adoperano sapientemente in Africa, dove la novella anti-occidentale e anti-americana trova un terreno molto fertile, soprattutto grazie all’esperienza coloniale del passato.
Gli Stati Uniti, insomma, hanno maturato una sorta di deficit di proiezione globale, dovuto forse anche alla crisi di una narrazione ideologica che si è sempre fondata su idealismi che, alla prova dei fatti, si sono dimostrati fumosi come l’esportazione di libertà, diritti e di democrazia. Un po’ come nella difesa dell’Ucraina, di interesse primariamente strategico ma che si è basata su una storia romanzata abbracciata da Biden che ha rispolverato “l’impero del male” nel secolo sbagliato.
Le principali partnership sorte nel corso dei decenni a guida americana, sono nate per un motivo ben preciso: il contenimento sovietico. Dopo la caduta del Muro di Berlino, però, con gli Stati Uniti unica superpotenza globale, le varie amministrazioni americane non sono riuscite a trovare una giustificazione più stabile al loro mantenimento.
Una narrazione imperiale si basa anche sulle capacità di comportarsi da impero e quindi sugli strumenti messi a disposizione per mantenere una certa egemonia e la capacità di dispiegarli. Se dal punto di vista tecnologico e militare gli USA restano la “potenza da battere”, su quest’ultima fattispecie, però, sono notevoli i passi indietro. L’ascesa di Obama si colloca come apogeo della capacità narrativa americana ma contiene anche gli elementi utili a comprendere quanto si sia creata una distanza fra “romanzo” e “realtà”. Da un lato il dialogo con il Medio Oriente, l’Iran e la religione islamica e dall’altro le primavere arabe; l’investimento sul soft power e la diplomazia e, di contro, la crisi economica – e di immagine – del 2008 partita proprio dagli Stati Uniti. E poi c’è l’opinione pubblica che, come il vento, governa la direzione della politica. Il consenso americano all’estero ha subito un tracollo, partito ma anche percepito dalla stessa opinione pubblica che ha chiesto un disimpegno globale degli Stati Uniti.
La crisi di consenso, poi, è stata raccolta da altri potenziali attori che si sono inseriti in quegli spazi vuoti che la retorica anti-americana e il progressivo disimpegno – fotografato, quest’ultimo, dal doloroso ritiro dall’Afghanistan dopo vent’anni – dell’impero americano dal teatro globale.
Le conseguenze di tutto ciò sono presto dette. Gli Stati Uniti restano un impero ma in un mondo non più unipolare ma multipolare. Quella americana non è l’unica nazione con vocazione imperiale (anche la Cina e la Russia lo sono) e se per tanto tempo quella di Washington è stata l’unica ad avere voce in capitolo, la presunta crisi del principale attore internazionale ha risvegliato le ambizioni degli altri. D’altronde, il discorso del “chi nasce impero, muore impero” vale anche per Mosca e Pechino.
Trump e l’eterno ritorno del passato
Il disegno imperiale di Donald Trump si manifesta anche in occasione delle dichiarazioni circa l’uso della forza per prendersi la Groenlandia, cioè la minaccia di un’espansione territoriale in piena regola e la violazione dello spazio di un’altra nazione sovrana. E lo stesso potrebbe dirsi per il canale di Panama, su cui il Tycoon ha messo gli occhi in funzione anti-cinese. Tale disegno, però, passa anche per quisquilie come l’idea di rinominare il golfo del Messico come golfo dell’America, poiché anche l’utilizzo della polarizzazione linguistica è un segno distintivo.
Dividi et impera, espansionismo, polarizzazione non sono invenzioni di Donald Trump ma un ricorso storico sdoganato dal ritorno degli imperialismi e dal mutamento dello scenario globale. La Russia nel 2022 ha invaso l’Ucraina, rispolverando l’idea che un impero, per mantenersi tale, debba espandersi e annettere territori, mentre la Cina – ormai è evidente – si sta preparando a muovere guerra a Taiwan. Gli imperi stanno tornando e gli Stati Uniti e la pax americana si stanno sgretolando. Quest’ultima si reggeva sulla capacità degli americani di mantenere l’equilibrio globale grazie alla pervasività dell’economia americana e alla sostenibilità di un modello che si reggeva soprattutto su basi economiche, oltre che militari. Ora, questo modello non è più sostenibile.
Dopo la caduta del muro di Berlino il politologo Francis Fukuyama profetizzò la “fine della storia“, sostenendo il fatto che, dopo la fine del comunismo sovietico, la democrazia liberale e il capitalismo sarebbero stati destinati a pervadere tutte le nazioni del pianeta. Trent’anni dopo, la previsione è stata ampiamente smentita. Nel cuore del XXI secolo, la retorica imperiale è tornata a occupare il centro della scena. Donald Trump non propone solo soluzioni muscolari ai problemi internazionali, ma incarna una vera e propria dottrina di restaurazione imperiale americana, un hard branding che ha il sapore del passato e che non fa prigionieri.
Donatello D’Andrea