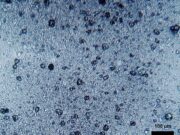L’8 e il 9 giugno 2025 si terranno cinque referendum abrogativi: quattro promossi dalla CGIL sui temi del lavoro, uno da +Europa per ampliare l’accesso alla cittadinanza. I quesiti intervengono su alcune tra le questioni più controverse degli ultimi vent’anni: flessibilità del lavoro, stabilità occupazionale, forme contrattuali ibride e possibilità per i giovani nati o cresciuti in Italia da genitori stranieri di ottenere la cittadinanza.
A pochi giorni dall’apertura dei seggi, è evidente come il vero oggetto del voto non sia tanto la modifica normativa in sé, quanto il messaggio politico che potrà scaturirne. Il raggiungimento del quorum, fissato al 50% più uno degli aventi diritto, è considerato altamente improbabile. Eppure, il Partito Democratico guidato da Elly Schlein, insieme a CGIL, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e altre forze dell’area progressista, ha scelto di impegnarsi pubblicamente nella campagna per il “Sì”. Una scelta non priva di contraddizioni e ambizioni simboliche. In questo contesto, il valore reale dell’iniziativa va misurato in termini politici più che giuridici: rappresentare, più che abrogare.
I quesiti, le fratture, il ritorno dei diritti sul lavoro
I primi quattro quesiti referendari, promossi dalla CGIL e sostenuti da un fronte largo di partiti d’opposizione, riguardano il superamento del Jobs Act e di alcune sue norme chiave, introdotte tra il 2014 e il 2016 dai governi Renzi. I promotori puntano:
- a ripristinare il reintegro per i licenziamenti ingiustificati;
- a estendere tale tutela a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione;
- a ristabilire l’obbligo di causale nei contratti a termine;
- a limitare le esternalizzazioni che generano rapporti di lavoro precari o opachi.
L’obiettivo, dichiarato, è quello di invertire la rotta della flessibilità imposta in nome della competitività, con l’intento di riportare al centro la dignità del lavoro e la stabilità contrattuale. Il Jobs Act, al di là delle formule tecniche, ha rappresentato per anni un punto di frattura: per molti, un compromesso necessario per favorire l’occupazione in un momento di stagnazione economica; per altri, l’inizio della marginalizzazione del lavoratore dipendente nel nome del mercato.
La CGIL, che ha promosso i quesiti, ha voluto imprimere un segnale politico forte, ribadendo il proprio ruolo non solo come sindacato ma come soggetto capace di orientare l’agenda pubblica. Dopo anni di marginalità percepita, l’obiettivo è tornare a esercitare pressione sul sistema dei partiti, riaggregando consensi attorno ai temi del lavoro, dei diritti sociali e della contrattazione collettiva. In questo senso, la raccolta firme e l’attivazione militante rappresentano già un primo indicatore della volontà del sindacato di uscire da una funzione esclusivamente difensiva.
Il quinto quesito, invece, proposto da +Europa, riguarda la cittadinanza: intende abrogare la norma che prevede un requisito di dieci anni di residenza continuativa per accedere alla cittadinanza italiana, riducendolo a cinque. La proposta mira ad allineare l’Italia agli standard di altri Paesi europei e a favorire un processo più inclusivo verso persone che, pur nate o cresciute nel nostro Paese, restano formalmente “straniere” per lunghi periodi.
Il quesito ha una portata simbolica e sociale rilevante, in particolare per i minori e i giovani adulti appartenenti alla cosiddetta “generazione invisibile”: cittadini di fatto, ma non di diritto. Si tratta di un tema che intercetta anche l’attenzione di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha sostenuto apertamente la campagna, in coerenza con un’agenda politica improntata alla difesa dei diritti civili e alla lotta contro ogni forma di discriminazione normativa.
Il dato evidente è che i promotori non si fanno illusioni. Nessuno si attende di raggiungere i circa 25,5 milioni di votanti richiesti per rendere validi i referendum. Le campagne si muovono su un piano diverso: non più quello dell’efficacia legislativa, ma della mobilitazione simbolica. L’obiettivo, condiviso da CGIL e Partito Democratico, è quello di riportare al centro temi rimossi dal dibattito pubblico: la precarietà strutturale, la fragilità contrattuale, l’accesso ai diritti fondamentali. E farlo in termini numerici: si punta a superare la soglia informale dei 12 milioni di votanti “Sì”, un dato che avrebbe un significato politico rilevante.
È qui che si inserisce l’elemento strategico. Il quorum formale diventa secondario rispetto a un quorum politico: mostrare di essere in grado di mobilitare più consenso dell’attuale maggioranza di governo. Non è, dunque, un referendum di contenuto. È un banco di prova sulla rappresentanza e sulla capacità di attivare un elettorato che da tempo si muove in modo frammentato e disilluso.
In questo quadro, il coinvolgimento del PD rappresenta una scelta di campo netta: in continuità con il profilo della sua segretaria, Elly Schlein, che già nel 2015 aveva espresso pubblicamente contrarietà al Jobs Act, e oggi prova a restituire al partito una linea riconoscibile sul tema del lavoro. La scommessa, più che normativa, è di legittimazione politica: essere riconosciuti come la forza che ancora può parlare, con credibilità, a lavoratori e lavoratrici.
Tra mobilitazione e rappresentazione: i veri obiettivi in gioco
L’impegno del Partito Democratico in questa tornata referendaria si inserisce in un percorso politico più ampio. La segretaria Elly Schlein, già durante le primarie del 2023, aveva indicato una netta discontinuità rispetto al ciclo riformista renziano. E i quesiti sul lavoro, in particolare, rappresentano una tappa coerente con quel posizionamento. La CGIL, promotrice dei referendum, fu un attore centrale anche nella vittoria congressuale di Schlein, sostenendo il suo profilo di segretaria alternativa alle élite interne del partito.
Oggi, il referendum diventa un’occasione per rinsaldare quell’alleanza. Il ritorno della CGIL come soggetto politico e non solo sindacale è evidente, e il partito cerca di recuperare un rapporto con il mondo del lavoro organizzato, dopo anni di tensioni e di rottura simbolica. Non si tratta tanto di tornare alla “foto di Vasto”, quanto di ricostruire una grammatica politica in grado di parlare a un elettorato che si è allontanato, e che guarda spesso con sfiducia anche le nuove leadership progressiste.
Il Movimento 5 Stelle partecipa con un profilo più defilato, ma con obiettivi convergenti. Per Giuseppe Conte, sostenere i referendum è un modo per rafforzare il legame con le istanze sociali più marcate, senza esporsi direttamente su un esito difficile da controllare. Il vantaggio tattico sta nella possibilità di intestarsi parte del merito in caso di mobilitazione significativa, e nel poter scaricare l’insuccesso formale su dinamiche esterne in caso contrario. Puro (e furbo) opportunismo politico.
Alleanza Verdi e Sinistra, pur con mezzi organizzativi più contenuti, ha sostenuto apertamente la campagna su tutti i quesiti, coerentemente con un progetto politico che insiste sulla difesa dei diritti sociali e su un’idea progressiva di cittadinanza. La partecipazione di AVS contribuisce a rafforzare l’immagine di un fronte largo delle opposizioni, che pur nella diversità di toni e priorità, tenta di offrire una narrazione alternativa al governo in carica.
All’interno del PD stesso non mancano le frizioni: diversi dirigenti locali non si sono spesi con convinzione nella campagna, e l’adesione formale non sempre si è tradotta in attivismo sul territorio. Le divisioni non riguardano solo l’impegno organizzativo, ma riflettono anche nodi politici più profondi. La linea Schlein, orientata a un recupero dell’identità di sinistra, è ancora percepita da una parte della classe dirigente come una deriva identitaria più che una strategia inclusiva. Lo stesso vale per la galassia delle opposizioni: mentre AVS e +Europa hanno assunto posizioni nette, altri soggetti hanno oscillato, evitando endorsement espliciti. La difficoltà di presentarsi come fronte coeso rischia di indebolire il potenziale politico del voto, e di consegnare all’elettorato un’immagine frammentata, poco leggibile. Tuttavia, la scelta della segreteria è stata chiara: dare forza politica a una battaglia simbolica, consapevoli del fatto che anche la testimonianza può produrre consenso, se costruita con coerenza.
Il senso della campagna non è quello di un’illusoria riforma referendaria, ma di una pressione politica. La cifra che conta non è il cambiamento normativo, bensì la capacità di mostrare un’alternativa. I referendum, in questo schema, diventano uno spazio di visibilità, una vetrina narrativa dove le opposizioni provano a raccontare una diversa idea di società, anche sapendo di non avere la forza numerica per realizzarla.
Il valore, quindi, non sta nell’illusione di “vincere”, ma nella possibilità di misurare una presenza politica. La soglia informale dei 12 milioni di voti — indicata ufficiosamente come traguardo dal gruppo dirigente del PD — ha senso solo se letta in chiave comparativa: più dei voti che la destra raccolse nel 2022, più di quanto molte forze di opposizione siano state in grado di mobilitare negli ultimi anni.
Il referendum dell’8 e 9 giugno sarà, con ogni probabilità, privo di effetto legislativo diretto. Ma non per questo irrilevante. In un contesto segnato da crescente disaffezione, anche le campagne referendarie possono avere una funzione politica: riportare al centro questioni sociali, offrire occasioni di mobilitazione, costruire coalizioni tematiche.
Che si tratti di diritti sul lavoro o di cittadinanza, il valore della consultazione non si misurerà nella cancellazione di una norma, ma nella qualità e quantità del consenso attivato. La politica si fa anche quando il diritto resta fermo. E i numeri — non quelli del quorum, ma quelli della partecipazione — diranno se questa campagna avrà lasciato un segno o sarà rimasta un esercizio simbolico.
Donatello D’Andrea