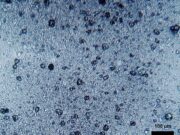Istanbul avrebbe dovuto ospitare il primo incontro diretto tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky dall’inizio della guerra russo-ucraina. La capitale diplomatica di un’Europa paralizzata e di un Medio Oriente ambizioso. Invece, è diventata la sede di una grande assenza. Nessuno dei due leader si è presentato. La tanto attesa svolta negoziale si è trasformata in un ennesimo teatro di ambiguità strategica e posizionamenti simbolici, lasciando sul tavolo più domande che soluzioni. Il vertice, iniziato venerdì, è durato meno di due ore e si è concluso con un solo risultato tangibile: un accordo per uno scambio di 1.000 prigionieri di guerra. Nessun passo avanti sul cessate il fuoco. Nessuna roadmap per la pace.
Nei giorni precedenti, Putin aveva rilanciato pubblicamente l’ipotesi di un faccia a faccia con Zelensky, presentandolo come risposta al cessate il fuoco di 30 giorni proposto dal gruppo Weimar Plus (Francia, Germania, Polonia e Regno Unito). Zelensky, cogliendo l’apertura, aveva dichiarato per la prima volta la sua disponibilità all’incontro, fissando l’appuntamento proprio a Istanbul. Ma giovedì, nella capitale turca, è atterrato solo il ministro ucraino della Difesa Rustem Umerov. Putin non si è visto. La Russia ha inviato una delegazione tecnica guidata da Vladimir Medinsky, già protagonista dei negoziati falliti del 2022. Un segnale eloquente.
La diplomazia del vuoto: Erdogan mediatore, Trump spettatore, Putin regista
L’immagine più eloquente è stata quella di Zelensky ad Ankara, visibilmente contrariato, mentre accusava il Cremlino di non aver preso sul serio la proposta negoziale. La delusione del presidente ucraino è esplosa in parole taglienti: la delegazione russa era composta da “oggetti di scena”, ha dichiarato. Secondo fonti ucraine, Mosca avrebbe avanzato richieste “irricevibili”, simili a quelle del 2022: neutralità dell’Ucraina, limiti alle forze armate, nessuna discussione sui territori occupati. L’incontro si è interrotto rapidamente, dopo meno di due ore di colloqui. Prima dell’incontro, la delegazione ucraina aveva incontrato informalmente rappresentanti di Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito, e ufficialmente anche il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ma tutto questo non è bastato a sbloccare il dialogo.
Putin, nel frattempo, si teneva lontano. La sua figura non è convocabile: il leader russo non si presta a comparsate. Per lui, la pace deve essere una narrazione di vittoria, non di compromesso. E finché non potrà venderla così, non ci sarà pace. A ciò si aggiunge un dato strutturale: l’economia russa è ormai militarizzata, dipendente dalla produzione bellica. Uscire dalla guerra significherebbe affrontare un collasso. Per questo motivo, ogni offerta di dialogo appare calibrata per guadagnare tempo, consolidare posizione e svuotare di significato ogni proposta altrui.
Zelensky, invece, aveva risposto con una mossa comunicativa calibrata: dichiarare la disponibilità a incontrare Putin direttamente, nella speranza di forzare il Cremlino a mostrarsi, o almeno a rispondere. Un modo per far uscire Putin allo scoperto e, allo stesso tempo, presentarsi come il leader della pace ragionevole, accettabile anche agli occhi degli scettici occidentali.
Ankara e Istanbul, nel frattempo, si confermano spazi geopolitici altamente simbolici. Dal 2022 a oggi, Recep Tayyip Erdoğan ha coltivato sistematicamente il ruolo della Turchia come mediatore centrale nelle crisi euroasiatiche. Dalla mediazione sul grano del Mar Nero al primo incontro tra ministri degli Esteri russi e ucraini ad Antalya, fino ai colloqui tecnici successivi, Ankara ha messo in campo un attivismo diplomatico che ha consentito alla Turchia di presentarsi come interlocutore credibile per entrambe le parti.
E poi c’è Donald Trump, l’unico leader capace di rivendicare centralità senza neppure esserci. Dai suoi tour in Medio Oriente, ha commentato che «la pace arriverà solo quando io e Putin ci guarderemo negli occhi». Una frase da reality show geopolitico, che dice tutto sullo stile trumpiano di intendere le relazioni internazionali: personalizzazione estrema, teatralità sopra la sostanza, ma anche una consapevolezza profonda che il potere oggi si esercita anche — e forse soprattutto — attraverso la narrazione.
La diplomazia del vuoto, quindi, non è mancanza di diplomazia. È diplomazia senza contenuti vincolanti, fatta di posture e allusioni, di incontri mancati e di assenze calcolate. È un teatro senza finale, in cui ogni attore recita la parte che serve al proprio pubblico interno. Nessuno vuole davvero chiudere il sipario, perché ogni atto prolungato consente di guadagnare tempo, risorse, posizionamento.
Tra propaganda e stallo: la crisi del negoziato internazionale
Il vertice mancato di Istanbul rappresenta un punto di svolta, non perché porti novità sostanziali, ma perché sancisce il fallimento della diplomazia classica. Quella fatta di inviti, delegazioni, mediazioni multilaterali e comunicati finali. Nel conflitto russo-ucraino del 2025, la pace è diventata una risorsa comunicativa, un bene simbolico da agitare o nascondere a seconda dei cicli interni dei diversi attori coinvolti.
Putin ha giocato d’anticipo per bloccare un’iniziativa europea che non controllava. Zelensky ha reagito forzando la mano, offrendo disponibilità diretta. Erdogan ha offerto lo spazio. Trump ha rilanciato su un piano personalistico. Ma alla fine, nulla si è mosso davvero. Nessuno dei protagonisti si è presentato a Istanbul. E la diplomazia ha perso ancora una volta.
Nel frattempo, sul campo, la guerra continua in uno stato di equilibrio instabile. Le forze in campo sono logorate da mesi di stallo operativo, mentre la retorica di entrambe le parti si irrigidisce. Gli attacchi continuano con cadenza regolare, ma senza mutare le linee strategiche. Il conflitto si è istituzionalizzato: è parte del paesaggio politico, parte della vita quotidiana. Non fa più notizia se non quando qualcosa devia dalla normalità della guerra. Questa normalizzazione del conflitto è il più grande fallimento della diplomazia internazionale.
Kyiv continua a ricevere sostegno militare, sebbene sempre più condizionato da vincoli politici, logistici e finanziari. Le elezioni nei paesi occidentali, le pressioni interne e le priorità strategiche altrove (come nel Pacifico o nel Medio Oriente) complicano ulteriormente la posizione ucraina. La popolazione ucraina vive ormai in uno stato di mobilitazione permanente, con un morale che resiste solo grazie al carisma della leadership e alla paura esistenziale di un ritorno sotto l’ombrello russo.
Sul fronte interno russo, il Cremlino ha intensificato il controllo informativo. La propaganda celebra ogni stallo come vittoria, ogni trattativa come conferma di forza. Sui media statali, il racconto del vertice di Istanbul è stato riplasmato per suggerire che la Russia resta padrona del tavolo, persino quando il tavolo è vuoto. Tuttavia, sotto traccia cresce il malcontento per un’economia di guerra che ha reso la vita ordinaria dei russi abbastanza complicata. I segnali sono rari ma evidenti: una crescente tensione sociale, una frustrazione silenziosa, un’apatia che si fa sintomo.
In questo contesto, manca anche una posizione chiara da parte della Cina. Pechino mantiene un basso profilo ufficiale, ma osserva con attenzione: da un lato non ha interesse in un crollo della Russia, dall’altro evita di esporsi troppo in processi negoziali che non può controllare. Il suo silenzio è una strategia: un’attesa lucida, finalizzata a capitalizzare qualunque scenario si realizzi — purché non venga destabilizzata l’architettura globale che consente a Pechino di espandersi senza interferenze.
Sul fronte spirituale, infine, si registra una rara presa di posizione da parte della Santa Sede. Papa Leone XIV, nel corso di un incontro con il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina Sviatoslav Shevchuk, ha ribadito: «Sono con il popolo ucraino. La Santa Sede continuerà a promuovere e creare tutte le condizioni necessarie per il dialogo». Una dichiarazione dal tono fermo, che conferma l’intenzione del Vaticano di giocare un ruolo moralmente attivo in una fase in cui le diplomazie formali vacillano.
L’Unione Europea, che con l’iniziativa Weimar Plus aveva cercato di rilanciare una leadership diplomatica, appare ora marginalizzata. Il suo ultimatum per il cessate il fuoco è stato rifiutato da Mosca e bypassato da Putin con la proposta di un incontro che non ha mai avuto luogo. Il rischio, ora, è che la guerra venga risolta altrove, secondo logiche bilaterali o triangolazioni opache. Con l’Europa ancora una volta spettatrice, non autrice, come ha sottolineato Mario Draghi in uno dei suoi profetici interventi.
Il mancato incontro di Istanbul è più di una delusione logistica: è una dichiarazione di impotenza collettiva. I leader globali invocano la pace ma si sottraggono al confronto diretto. Le delegazioni si incontrano, ma senza mandato politico pieno. Le città ospitano, ma non decidono. In questo contesto, la guerra russo-ucraina si sta trasformando in una guerra eterna, fatta di tregue fallite e incontri fantasma.
Putin si conferma abile nel gestire il tempo strategico: accetta di trattare, ma solo alle sue condizioni. Zelensky cerca di uscire dall’isolamento simbolico, ma si scontra con un muro di cinismo. Erdogan mantiene il suo ruolo da intermediario globale, ma non ha leve per imporre nulla. Trump, infine, agisce come attore ombra: onnipresente nei discorsi, assente nei fatti, ma sempre pronto a entrare in scena al momento giusto.
Il prossimo futuro non promette svolte facili. Ma una cosa appare chiara: finché le leadership globali tratteranno la pace come una narrazione e non come un obiettivo operativo, le guerre continueranno a essere amministrate piuttosto che risolte. E Istanbul, con il suo vertice mancato, ne è la metafora perfetta.
Donatello D’Andrea