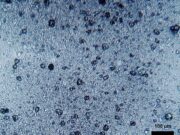I dazi, i negoziati di pace avviati a Riad con la Russia di Putin senza il coinvolgimento dell’Europa e dell’Ucraina, gli attacchi alla stabilità europea del vicepresidente Vance: con l’elezione di Donald Trump l’aria è cambiata e i rapporti fra gli Stati Uniti e l’Europa hanno intrapreso la strada della competizione e degli “sgambetti diplomatici”.
L’Unione Europea è la grande esclusa dai tavoli commerciali e negoziali che la nuova amministrazione americana sta aprendo dall’insediamento del neo-presidente e sta pagando le conseguenze – le ennesime – della totale assenza di una struttura in grado di reggere gli urti che le lunatiche oscillazioni umorali che le elezioni presidenziali provocano dall’altro lato dell’oceano. La subalternità all’atlantismo, non visto come alleato bensì come “padre padrone”, provoca esattamente questo: al cambio della “dottrina” corrisponde una crisi interna delle contromisure europee. Dopo l’elezione del 2016 di Donald Trump accadde esattamente la stessa cosa, da allora l’Europa ha imparato poco o nulla a quanto pare.
Chiaramente non è possibile additare la responsabilità di quanto sta accadendo al presidente in carica, anzi. Anche prima, con la guerra Israele-Hamas, l’Europa ha rivestito i panni del mediatore in ombra, senza alcuna capacità di intervento, lasciando ai singoli stati la libertà e la facoltà di rilasciare dichiarazioni conflittuali tra di loro (o di sostegno alla causa palestinese oppure di appoggio alle decisioni di Israele). Dal suo insediamento, Donald Trump ha escluso l’Europa anche da quel tavolo, proponendo un piano per il futuro della Striscia di Gaza.
Dal 20 gennaio, l’approccio americano al mondo è cambiato e i leader europei si sentono più soli del previsto. Dal 12 marzo partiranno i dazi commerciali decisi con un ordine esecutivo di Trump e la Commissione europea dopo una dichiarazione battagliera ha voluto evitare una prova di forza, cercando un accordo per alleggerire il confronto. La verità è che la dottrina Trump spaventa per la sua imprevedibilità ma anche un analisi in senso “statunitense” del problema, oscurerebbe quella che è la dolora realtà dei fatti: a qualsiasi dottrina americana, l’Europa è incapace di proporne – e contrapporre – una propria. Per ora, l’unica strategia che sembrerebbe essere stata messa in campo è quella della subalternità agli umori e ai desiderata delle varie amministrazioni. Qualcosa che non paga e che finirà per appiattire le leadership europee, sempre più in difficoltà nel cogliere e affrontare le sfide che la politica internazionale metterà loro davanti.
La crisi del progetto europeo e la visione trumpiana
Appare chiaro e lapalissiano che la crisi interna del progetto europeo renda molto più affascinante qualsiasi progetto “individualista” che arriva dall’altro lato dell’oceano, soprattutto se ad attuarlo è un “uomo forte” le cui proiezioni in miniatura occupano stabilmente gran parte delle cancellerie europee. La destra sovranista europea, da sempre nemica dell’unità continentale, trae sostegno e “sponde” dagli Stati Uniti di Donald Trump, quale punto d’appoggio e di forza per le loro politiche legittimanti una visione prettamente nazionale e non comunitaria della politica internazionale.
Dal canto suo, il Tycoon trae enorme vantaggio da questa visione del mondo in quanto facilita enormemente il suo approccio e la capacità persuasiva degli Stati Uniti trovandosi in una posizione di netta forza rispetto ai singoli stati europei. Questo suo modo di vedere le cose non è nuovo: anche nel suo primo mandato presidenziale, i rapporti con l’Unione Europea erano così impostati. L’Europa, dal canto suo, è sostanzialmente abituata a subire in silenzio il cambiamento di umori di Washington, il quale oscilla fra protezionismo e multilateralismo, senza mai battere ciglio e adeguandosi – con difficoltà – alle esigenze dell’alleato. Questa volta, però, le cose sono diverse. Non si parla più di una tendenza elettorale bensì di un progetto in estrema crisi e senza più una leadership in grado di tenere testa, a fasi alterne, agli Stati Uniti.
La fine dell’era Merkel ha privato l’Europa di una guida e il trionfo delle destre filo-trumpiane rende tutto più difficile. Senza una leadership e con franchi tiratori interni, resistere alla spinta di Donald Trump all’unità continentale diventa difficile. Fu difficile allora, con la Brexit, la quale rappresenta l’esempio più lampante di come le forze anti-europeiste siano così forti da cambiare le sorti del continente. Tra l’altro, all’epoca, Trump non era stato ancora eletto presidente.
L’Europa, agli occhi del Tycoon, non è un’alleata. O meglio, lo è soltanto nella misura in cui sia intenzionata ad adeguarsi ai desiderata degli Stati Uniti. Il mondo che si schiude a tale visione del mondo – una sorta di “dottrina Trump” o “Realpolitik trumpiana” – le tre categorie con cui è possibile approcciarvisi sono: alterità, subalternità e competizione.
Il Presidente ha apertamente denunciato, assieme al suo vice, l’alterità europea attaccando gli stati continentali e accusandoli – tra le altre cose – di essere pavidi di fronte alle “legittime richieste” di un contributo maggiore, dal punto di vista militare, nella NATO. Gli USA si sono sempre fatti carico della difesa europea, con ben 90mila soldati schierati nel continente e, nella visione di Trump, l’ingratitudine europea di fronte a richieste considerate legittime è uno schiaffo morale alla “disponibilità” americana. La subalternità, invece, si articola nell’imposizione degli oneri della ricostruzione dell’Ucraina, molto probabilmente amputata di alcuni suoi territori, e della sue garanzie securitarie (da garantire con il dispiegamento di forze militari). Entrambe questioni di cui gli Stati Uniti non vogliono farsi carico.
I dazi come leva politica
La competizione si consuma, invece, con i dazi. Si tratta delle vere e proprie ritorsioni che, in teoria, dovrebbero servire a riequilibrare la bilancia commerciale import-export, enormemente sproporzionata a favore dei Paesi europei. Tutte le analisi economiche ritengono che con l’imposizione di queste ritorsioni commerciali a perderci sarebbero anche gli americani. I produttori esteri potrebbero ridurre i listini dei beni per mantenere quote di mercato, gli americani potrebbero aumentare i prezzi a causa dell’aumento del costo dei componenti importati e perché dovrebbero sostenere i costi della produzione locale. Il rischio inflazionistico sarebbe dietro l’angolo, così come quello di una recessione. Uno scenario non proprio auspicabile per l’economia americana. Un’eventuale guerra commerciale con mezzo mondo sarebbe catastrofica per tutti, dunque. Anche per Trump.
Ma il Tycoon questo lo sa. I primi dazi, infatti, non li ha imposti né all’Europa e nemmeno alla Cina bensì al Canada e al Messico e i motivi sono chiari, a questo punto: sono due economie aperte e che dipendono dalle esportazioni, interconnesse a quella americana e che sopporterebbero un costo più elevato di quello che possono infliggere agli USA in caso di “contro-dazi”. Tra l’altro su ciò che davvero potrebbe “far male” agli Stati Uniti, cioè il petrolio canadese – estratto al confine con gli states – Trump ha ben pensato di emanare dei “dazi ridotti” e, quindi, simbolici.
L’aver scelto questi due Paesi rende Trump imprevedibile e quindi, in teoria, ciò dovrebbe aumentare la sua posizione negoziale. Sulla Cina, invece, i dazi sono davvero simbolici – al contrario di quanto dichiarato in campagna elettorale – e quindi funzionali più ad un negoziato che ad una vera guerra commerciale. Dunque, Donald Trump cui prodest?
I dazi, secondo questa visione, rappresenterebbero solamente una leva negoziale per riuscire ad estrapolare singoli accordi con gli stati nel modo più vantaggioso possibile per gli Stati Uniti. Washington è disposta a pagare un costo economico in cambio di un vantaggio politico non misurabile in numeri bensì in “influenza”. Una strategia che ha funzionato, in quanto Messico e Canada si sono seduti al tavolo per negoziare e che, a meno di smentite, potrebbe funzionare anche con l’Unione Europa. Stando alle prime fonti, Bruxelles avrebbe contrattato una “tregua” in cambio di un maggiore investimento in armi e difesa. D’altronde, non poteva essere altrimenti vista la posizione di netta forza con cui gli Stati uniti si approcciano ai singoli stati europei – e l’ottusità di questi ultimi di trattare singolarmente e non come Unione. Ottusità data dal non riuscire a comprendere quanto sia il dato politico a guidare le scelte di Donald Trump e non solo il mero interesse economico. È il ritorno della “politica” come categoria di pensiero e di azione che prevale sulla scelta economica. Un approccio estraneo ad un’Europa dei “conti in ordine”, che non ha mai agito in questo modo, credendo che bastasse un visione del mondo da “potenza erbivora” o geo-economica per trovare le proprie coordinate in politica estera.
Non esistono special relationships che tengano in questo caso. In politica estera la gratitudine non esiste, così come gli sconti. I dazi di Trump non risparmieranno nessuno – nemmeno l’Italia di Giorgia Meloni – ed è per questo motivo che si rende necessaria una risposta unitaria in grado di riequilibrare il braccio di ferro fra gli Stati Uniti e l’Europa. Si vocifera, a questo proposito, che la prova di forza serva agli americani per allontanare il continente dalle grinfie della Cina. Un obiettivo perseguito – se veritiero – con la tipica violenza di chi non fa sconti a nessuno, nemmeno agli alleati. E in questo gioco delle parti tra due potenze, emerge in modo ancora più evidente tutta l’inadeguatezza della classe dirigente europea che preferisce sedersi al tavolo con un padre-padrone anziché correre ai ripari e utilizzando il grido d’allarme di Macron che, pur nella classica vanità francese, ha come suo fondamento un messaggio chiaro e veritiero: bisogna unirsi per non morire. Un messaggio più politico che economico, in linea con una dottrina – quella del Tycoon – che di politico ha molto più di quello che sembra e che potrebbe essere colto dalle cancellerie europee, male avvezze al dare il giusto valore alla politica, preferendole quasi sempre l’economia. Ora è il momento della prima.
Donatello D’Andrea